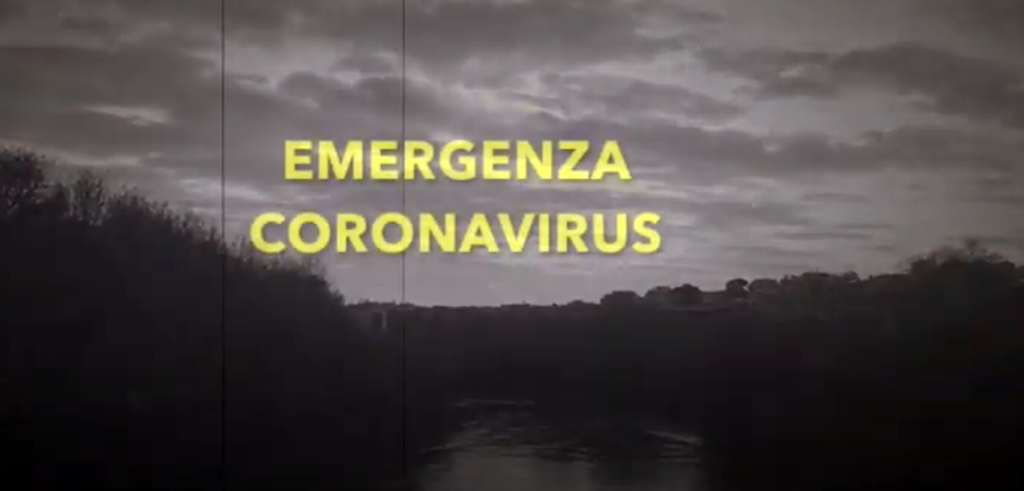Diciamolo: tutte queste immagini di Roma e delle città italiane deserte ci piacciono: esteticamente perfette, ci riportano a una visione astratta dell’arte, del paesaggio, dell’urbanistica. E’ l’Italia delle vecchie foto Alinari, dove l’elemento umano è un puro accidente. Roland Barthes già notava in Miti d’oggi che nelle guide blu Michelin città e monumenti vivono nell’assoluto (1) e lo stesso vale per le guide del Touring Club Italiano. Ma piace anche l’idea di una metropoli invasa da cinghiali, anatre selvatiche con paperotti al seguito e magari le capre che brucano l’erba che cresce tra i sampietrini: Madre Natura si sta riprendendo quello che le appartiene e fa piacere vedere i delfini a Trieste, a Venezia e a Salerno, o l’acqua del Po di un colore diverso. Se un barile di petrolio vale oggi meno di un dollaro, vuol dire che tutto è fermo. Ma assai prima del compiaciuto moralismo ecologista (al quale Greta Thunberg finora non si è associata) ci sono state nei secoli centinaia di riflessioni morali sulle rovine della Roma imperiale: a partire dal Medioevo, viaggiatori e pellegrini confrontano fino alla noia la visione dell’Urbe deserta e degradata con la nuova Roma cristiana risorta dalle ceneri pagane. Altrettanto scontata è la visione del’epidemia come castigo biblico per i nostri peccati, stavolta anche ecologici. Ma ora si è aggiunta una variante: le ricche chiese evangeliche americane e alcuni settori ultraconservatori cattolici vedono nella solitudine di Papa Francesco in piazza san Pietro la punizione divina per il pontefice eretico, socialista e anticristo. Niente di nuovo, visto che l’AIDS fu considerato il castigo divino per Sodoma ma non per Gomorra. Stupisce però che un gesto simbolico così forte come quello di Papa Francesco sia stato interpretato ora in modo laico – per Sgarbi è il fallimento della religione (2), ora in modo paranoico, anche se certe correnti religiose non sono nuove a interventi estremi, al limite del patologico. Diversa la reazione islamica: all’epoca delle conquiste l’epidemia riguardava le affollate città infedeli (quindi era meritata) e in seguito – quando toccò a loro – fu vista come equivalente alla morte in guerra o volontà divina (3). Come si vede, le metafore belliche oggi tanto frequenti non sono nuove: la malattia rimanda alla debolezza umana, la guerra al sacrificio collettivo per la vittoria finale. Ma le grandi religioni oggi sembrano più caute: anche se per l’ISIS la pandemia è il flagello contro gli infedeli, questo non rappresenta il pensiero di tutti gli islamici. Piuttosto, le grandi religioni monoteiste si stanno responsabilmente adeguando a tutte le disposizioni sanitarie, ma promuovendo nel contempo la preghiera in casa, la meditazione personale, la fratellanza universale e l’armonia con la natura; in sostanza, una forte spiritualità svincolata dalla rituale riunione collettiva dei fedeli. E come negli anni passati la Radio Vaticana diffondeva in tutto il mondo il messaggio del Papa, oggi ben altri mezzi telematici permettono la partecipazione collettiva al positivo messaggio di speranza.
Ma torniamo all’immagine di Roma come non l’abbiamo mai vista. Tra tanti video ne voglio valorizzare uno, breve (3 minuti), girato il 14 marzo, senza droni e in un quartiere – Testaccio, Porta Portese – diverso dalle solite cartoline. L’ha girato Roberto Di Vito, un videomaker romano indipendente, autore anche di medio metraggi, il migliore dei quali è “Bianco” (2011, 78”) (4). Non è la solita carrellata sulle piazze e i monumenti di una Roma stupenda perché deserta; ricorda piuttosto certe sequenze del regista sovietico Tarkovskji o del suo allievo Lopushanskj, caratterizzate da ambienti reali resi alieni dal disuso, svuotati della presenza umana. Vediamo dunque il video “Emergenza Coronavirus”.
Le immagini sono drammatiche, evocatrici, efficaci nella loro essenzialità, quasi prese di peso da un film di fantascienza. Eppure la videocamera inquadra elementi reali, banali, i quali riescono stranamente a trasformare un video di tre minuti in un documento storico mai visto prima. Inquietante la voce fuori campo che grida: ” Dove sei? Dove sei amico. Vieni qui“. Non sappiamo chi la pronuncia e perché, ma risuona in un vuoto. Ma è un vuoto metafisico, simbolicamente saturo. Tutto questo è ottenuto con mezzi poveri, essenziali, da vero regista indipendente: il valore aggiunto viene prodotto attraverso un procedimento per sottrazione. E qui Di Vito è coerente: continua un discorso iniziato con “Ai confini della città” (1998, 34”), amaro apologo di una civiltà e di più generazioni allo sbando, all’interno di una Roma inedita, svuotata, pronta alla desertificazione che avverrà da un giorno all’altro appena una ventina d’anni dopo.
Note:
- Roland Barthes, Miti d’oggi. Torino, Einaudi, 1962 e successive ristampe.
- Lo stesso Sgarbi ha difeso invece il parroco Lino Viola quando questi ha voluto celebrare messa con un ristretto numero di fedeli e sono intervenuti i Carabinieri. In questo caso Sgarbi è intervenuto in nome delle libertà sancite dalla Costituzione.
- La peste di Giustiniano. Seconda parte: l’influenza dell’epidemia sulla formazione dell’impero islamico, a cura di Sergio Sabbatani et alii, in Le infezioni in Medicina, 2012, 3.
- Info ufficiali: https://it.linkedin.com/in/roberto-di-vito-16194044 ; https://www.mymovies.it/filmografia/?r=32162 ; https://www.facebook.com/roberto.divito2 ; https://www.comingsoon.it/personaggi/roberto-di-vito/131417/biografia/