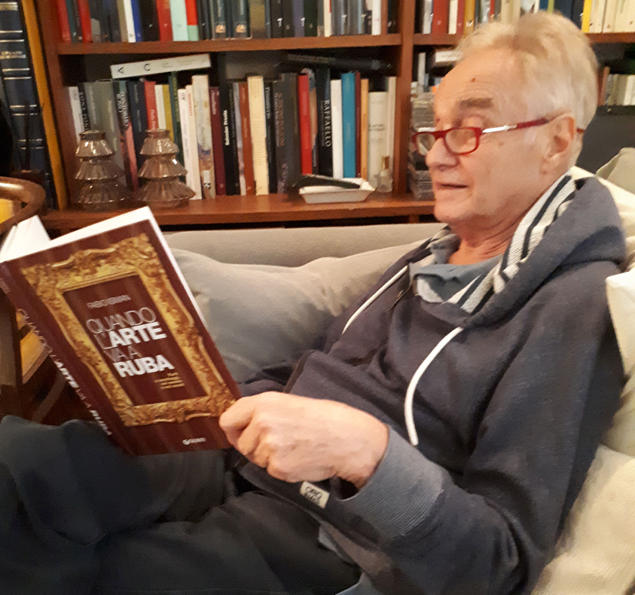Pochi mesi fa, il 14 luglio, il Ministero della Difesa aveva rinnovato insieme al Ministero della Cultura la firma del protocollo d’intesa (la prima risale al 6 luglio 2016) per una eventuale concessione della gestione economica dei Musei storici militari italiani (1). L’accordo era stato ampliamente pubblicizzato: interessava 15 musei militari in 8 città italiane e prevedeva che la valorizzazione del patrimonio museale e la gestione economica si realizzasse “promuovendo una gestione economica efficiente ed efficace, anche mediante l’affidamento a terzi” (2). I musei qui indicati erano quelli della Fanteria, Granatieri, Motorizzazione, Genio – tutti a Roma – e della Marina a La Spezia. Ma proprio l’affidamento dei musei ai privati per renderne economicamente vantaggiosa la gestione ha trovato la ferma e convinta ostilità delle Associazioni d’Arma, che hanno espresso tramite Assoarma le loro riserve (3) così riassumibili: i musei militari sono permeati di valori ben diversi da finalità strettamente economiche e dunque non trasferibili ad ambienti culturalmente e ideologicamente estranei. Posizioni ribadite e amplificate nella pubblicistica di settore (4), dove si insiste sulla valenza di “Sacrario” dei musei militari. Di fatto le ditte invitate non hanno mostrato interesse alcuno, ma nonostante il parere delle Associazioni si era deciso di prorogare il bando, ora ritirato per mancanza di adesioni. E’ chiaro che i privati si sono fatti i conti in tasca, per quanto vantaggiosa sembrasse l’offerta e sottovalutando a mio parere le potenzialità dei musei e anche dei loro spazi esterni. Ma è proprio la stampa di settore a indicare senza volerlo i limiti dei nostri musei militari: proprio perché sacrari e raccolte di cimeli essi si pongono al di fuori della moderna gestione museale. Chi voglia aggiornarsi sull’argomento si guardi p.es. il sito del National Army Museum britannico, il museo dell’Esercito britannico (5). E’ un capolavoro di accoglienza: le ampie collezioni sono contestualizzate, la parte didattica è molto curata e una serie di esposizioni temporanee spazia letteralmente su più fronti. Inoltre ci sono una biblioteca e un archivio consultabili, quindi il museo è anche luogo di ricerca storica, né è esclusa la parte commerciale: nel negozio interno si vendono libri e gadgets. Passando invece a casa nostra, se alcuni musei sono ben organizzati, come quello dell’Aeronautica sul lago di Bracciano, la maggior parte di essi sconta non solo la mancanza di investimenti adeguati, ma anche alcune criticità strutturali, prima fra tutte la mancanza di una formazione specifica per i direttori, in genere scelti fra ufficiali d’arma in fine carriera; una selezione che non garantisce da sola competenza e progettualità. L’ideale sarebbe sottoporre i futuri direttori di museo militare almeno a un corso di formazione gestito dal Ministero della Cultura, il quale dovrebbe anche formare il personale addetto alla catalogazione e alla conservazione del materiale affidato. Per anni i reperti sono stati schedati senza seguire le linee guida della catalogazione museale fissati dall’attuale Ministero della Cultura, e troppe volte il materiale non esposto e conservato in magazzino – spesso donazioni private – è stato accantonato senza una catalogazione scientifica, col rischio reale di una sostituzione o sottrazione di cimeli a favore dei collezionisti. Un’altra carenza di gestione riguarda l’accoglienza. Si può anche spendere per l’immagine, ma se il museo è aperto solo la mattina e il personale militare lavora solo fino al mezzogiorno del venerdì, al museo non ci va nessuno se non le scolaresche e qualche appassionato, mentre i musei civici hanno da tempo modulato i propri orari di apertura sulle esigenze dei visitatori. In questo campo le Associazioni d’Arma, se hanno volontari disponibili, potrebbero contribuire alla gestione dei musei militari, sia nella sorveglianza dei gruppi di visitatori che nella gestione delle visite guidate, oltre che nei servizi di biblioteca e di archivio, lasciando ad eventuali ditte private la gestione della ristorazione o la promozione delle mostre temporanee e dell’ufficio stampa.
****************************
Note:
- htpps://www.difesa.it/PrimoPiano/Firmato_protocollo_per_la_valorizzazione_dei_musei_militari.aspx
- htpps://www.difesaservizi.it/musei . Difesa Servizi S.p.A. è una società per azioni di cui è unico titolare il Ministero.
- Assoarma, verbale n. 04/21 riunione n. 171 del 1.07.2021, § 3: Punto di situazione sull’eventuale concessione della gestione economica dei Musei Storici Militari Italiani.
- Il Granatiere, n.3 /2021. Editoriale a firma del presidente nazionale ANGS gen. Garassino.
- https://www.nam.ac.uk/