 Sulla storia del Mare nostrum c’è una stupenda letteratura: dall’opera di Pirenne a quella di Braudel passando per Matvejevic, Quilici e Cardini (1). Questo breve libro di Luciano Canfora (2016) in meno di cinquanta pagine li sottende e aggiunge di suo. Era in realtà il testo di una conferenza – un po’ come le Lezioni americane di Calvino – e in fondo, diciamolo, i piccoli libri sono sempre i migliori: leggibili, concisi, razionali.
Sulla storia del Mare nostrum c’è una stupenda letteratura: dall’opera di Pirenne a quella di Braudel passando per Matvejevic, Quilici e Cardini (1). Questo breve libro di Luciano Canfora (2016) in meno di cinquanta pagine li sottende e aggiunge di suo. Era in realtà il testo di una conferenza – un po’ come le Lezioni americane di Calvino – e in fondo, diciamolo, i piccoli libri sono sempre i migliori: leggibili, concisi, razionali.
Intanto, il Mediterraneo è un mare chiuso dalle colonne d’Ercole; il canale di Suez prima non c’era, al punto che nella geografia di Tolomeo l’oceano Indiano era visto come chiuso e simmetrico. Platone però affermava (2) che il Mediterraneo è solo una piccola parte della terra, in cui “abitiamo come formiche o rane attorno allo stagno”, dimostrando dunque di vedere molto più in là degli altri. Ma quando è stato unificato il Mediterraneo? Un primo tentativo lo fanno i Greci di Siracusa per eliminare i Fenici dalla Sicilia, seguiti dagli Elleni ateniesi che cercano di conquistare Siracusa (3). Ma Atene e Sparta possedevano risorse limitate: una aveva la flotta, l’altra la fanteria. Con la prima si possono esigere tributi dai porti, con la seconda si tiene il terreno, ma per governare sul serio ci vuole un Impero. La risposta è quindi ovvia: il Mediterraneo diventa un lago quando Roma prima unifica prima l’Italia e poi elimina Cartagine e trasforma lo spazio intorno alla penisola in Mare nostrum. Quando discuto con uno straniero non è facile spiegare per quale motivo l’Italia è da secoli e anche oggi luogo d’invasione invece che padrona di un mare nel quale occupa una posizione assolutamente centrale. E l’ultima figuraccia risale a ieri, quando il nostro vuoto politico è stato occupato dalla Francia di Macron. Ma le invasioni sono di antica data: il Mediterraneo è come un ampio anello le cui rive e isole sono state raggiunte prima o poi da tutte le migrazioni afro-asiatiche. “Rodon”, la rosa, è una parola che i Greci hanno trovato sul posto, e chissà quante altre. Se l’Europa è un concetto medievale, il ratto di Europa è ancestrale: come a dire che ciò che vien da fuori, una volta varcati i Dardanelli diventa altro. Ma proprio sul Bosforo – a Troia – si svolge la guerra più antica di cui abbiamo testimonianza grazie a Omero. L’Iliade è la guerra degli Achei – Elleni, non asiatici – contro i popoli d’Anatolia. Gli stessi Elleni secoli dopo bloccheranno i Persiani di Serse e i loro discendenti romanizzati saranno sconfitti e occupati per sempre dai Turchi solo nel 1453, quando cade dopo mille anni l’Impero Romano d’Oriente. Alessandro Magno aveva orientalizzato il proprio potere per proiettarlo in Asia ma il suo impero fu breve, mentre l’impianto fondato dall’imperatore Costantino si dimostrò ben più solido e duraturo. Questo per dire che il Mediterraneo presenta una frattura originaria che non contrappone solo nord a sud, ma piuttosto ovest contro est. Canfora nota con preoccupazione la recente, progressiva egemonia della Turchia di Erdogan su Siria, Egitto e Libia, sviluppata ora appoggiando l’Isis, ora proponendosi nella mediazione fra le parti in conflitto (è di oggi il vertice di Tunisi), e la vede come una costante: al mare cercano di arrivare i popoli che scendono dalle aride montagne, mentre i popoli civilizzati cercano sempre di combattere i barbari, anche se prima o poi l’esito è scontato. Anche la guerra moderna vive di proiezione ancestrale, e non importa se non sappiamo più combattere e apriamo la porta all’invasore: è il principio quello che conta, la memoria è indelebile. Ovviamente parlo per metafore, quindi nessuno si offenda.
La frattura tra nord e sud si deve invece all’espansione dell’Islam, e qui la tesi di Pirenne, anche se formulata nel 1939, resta valida, nonostante il revisionismo di Cardini, il quale sembra rimuovere il concetto stesso di conflitto per trasformarlo in uno scambio tra culture diverse. E’ vero che certi traffici non si sono mai interrotti del tutto, ma la storia del Mediterraneo è una storia di guerre, di uomini finiti in fondo al mare e di rotte commerciali da difendere o sfruttare a tutti i costi. I secoli bui si devono anche all’interruzione del flusso di cultura e merci tra Oriente e Occidente, come la rinascita segue la ripresa dei flussi arabi che dall’Oriente tornano in Spagna, fin quando i Turchi – musulmani ma alieni – s’impongono prima su Baghdad e poi su Bisanzio. Una storia di lacerazione, ma anche d’incroci e scambi di ogni genere. L’essenza del Mediterraneo è la mescolanza, come diceva il compianto Pino Daniele.
A ricomporre l’unità del Mediterraneo sarà nel secolo XIX il colonialismo europeo: Marocco, Algeria e Tunisia diventano francesi, la Libia italiana, l’Egitto inglese. Ma è un dominio che dura poco più di un secolo, e si dimostrerà per quello che era: superficiale. Come un secolo – dal 1918 a oggi – dura l’assetto del Medio Oriente, seguìto alla dissoluzione dell’Impero Ottomano (accordi Sykes-Picot) e la nascita di nuovi stati. Fino all’attuale rinascita del Califfato o Daesh che sia, che spazza i confini geometrici tirati sulla carta con squadra e compasso. E una storia non finita, visto che ora si prevede il riflusso dei guerrieri verso la Libia e l’Africa subsahariana. L’autore ovviamente non è un indovino, quindi non può dire come andranno le cose. Fa comunque un’ultima osservazione: la Siria – tirannide minacciata da ben altra tirannide – è il paradigma della fine di un progresso laico, di quel nazionalismo militare modernista che aveva avuto nell’Egitto di Nasser il suo più ambizioso protagonista. Sogno infranto – aggiungo io – dall’unico stato realmente moderno e “occidentale”: Israele.
Infine, è inquietante pensare a una frase di Braudel, già citato: “L’unico destino dell’Africa è invadere l’Europa. L’unico destino dell’Europa è accoglierla”. E’ solo questione di tempo? In mancanza di una vera politica, sicuramente.
 ****************************
****************************
Mediterraneo, una storia di conflitti.
Della difficile unificazione politica del mare nostrum in età classica (e oggi?)
Luciano Canfora
Editore: Castelvecchi (Irruzioni), 2016, pp. 43.
Prezzo: € 5,00
EAN: 9788869447129
****************************
NOTE
1. Maometto e Carlomagno / Henry Pirenne, 1939 e ristampe; Il Mediterraneo : lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione / Fernand Braudel ; con la collaborazione di Georges Duby, 1987; Breviario mediterraneo / Predrag Matvejevic ; introduzione Claudio Magris, 1988; Mediterraneo / Folco Quilici, 1980; Incontri (e scontri) mediterranei : il Mediterraneo come spazio di contatto tra culture e religioni diverse / Franco Cardini, 2014. – sono cinque libri di cui non si può fare a meno, che e offrono una scelta di documenti e opinioni affascinanti.
2. Fedone, 109 b
3. “Greci” erano chiamati esattamente gli Elleni che avevano colonizzato la Magna Grecia, come dire “Americani” invece che “Inglesi”. Se volete far felici i vostri amici greci, chiamateli sempre “voi Elleni”.

 Denis Mack Smith lo vidi quando ero studente di liceo: al ridotto del teatro Eliseo (oggi Piccolo Eliseo) c’era l’abitudine dei Martedì letterari, e lo storico fu invitato a presentare al pubblico italiano la sua Storia d’Italia dal 1861 al 1969. L’opera era stata pubblicata da pochi mesi ma già aveva creato un vespaio: rifiutata dall’Accademia, piaceva invece al pubblico italiano, sedotto dallo stile semplice della narrazione, dalla precisione delle fonti e dal taglio innovativo dell’analisi storica. Ostile invece la casta universitaria e istituzionale, a cominciare dall’Istituto italiano per il Risorgimento e giù a caduta le varie cattedre di storia moderna. Quando feci l’esame di Storia del Risorgimento nel 1973 con la Morelli – non per niente detta “la vedova di Mazzini” – guai a nominare “l’inglese”. Il testo di base era ancora l’Omodeo, dove c’erano frasi come questa: “<Cavour> da giovane si coricava sognando non di diventare un giorno primo ministro del Regno Sabaudo, ma bensì primo ministro del Regno d’Italia”. Niente di strano che noi giovani fossimo invece affascinati da un testo che, oltre ad essere scritto da un allievo di Trevelyan (molto apprezzato da mio padre), guardava la nostra storia dall’esterno e senza pregiudizi: Mack Smith non era in quota a nessuno, non cercava voti dai partiti né una cattedra universitaria in Italia.
Denis Mack Smith lo vidi quando ero studente di liceo: al ridotto del teatro Eliseo (oggi Piccolo Eliseo) c’era l’abitudine dei Martedì letterari, e lo storico fu invitato a presentare al pubblico italiano la sua Storia d’Italia dal 1861 al 1969. L’opera era stata pubblicata da pochi mesi ma già aveva creato un vespaio: rifiutata dall’Accademia, piaceva invece al pubblico italiano, sedotto dallo stile semplice della narrazione, dalla precisione delle fonti e dal taglio innovativo dell’analisi storica. Ostile invece la casta universitaria e istituzionale, a cominciare dall’Istituto italiano per il Risorgimento e giù a caduta le varie cattedre di storia moderna. Quando feci l’esame di Storia del Risorgimento nel 1973 con la Morelli – non per niente detta “la vedova di Mazzini” – guai a nominare “l’inglese”. Il testo di base era ancora l’Omodeo, dove c’erano frasi come questa: “<Cavour> da giovane si coricava sognando non di diventare un giorno primo ministro del Regno Sabaudo, ma bensì primo ministro del Regno d’Italia”. Niente di strano che noi giovani fossimo invece affascinati da un testo che, oltre ad essere scritto da un allievo di Trevelyan (molto apprezzato da mio padre), guardava la nostra storia dall’esterno e senza pregiudizi: Mack Smith non era in quota a nessuno, non cercava voti dai partiti né una cattedra universitaria in Italia. Ma il nostro autore avrebbe ancora scandalizzato il belpaese quando si occupò di Mussolini, attirandosi anche gli strali di De Felice e levandogli il monopolio del revisionismo. A leggere Le guerre del Duce (1976) e Mussolini (1982) c’è da divertirsi, se non fosse in realtà una tragedia nazionale. In sostanza, Mussolini era un opportunista ossessionato dal Potere, prigioniero della sua autoesaltazione, padrone dei mass-media dell’epoca, intelligente in politica ma autocratico e incompetente sul piano militare. Dati alla mano, Mack Smith dimostra che il Fascismo (“parola italiana per un’invenzione italiana”) ha sempre cercato la guerra ma non si è mai preparato per farla, coi risultati che sappiamo. Purtroppo Mack Smith non si è mai occupato di Berlusconi. Ha seguito amorevolmente la nostra storia fin dove la sua cultura e la sua capacità di analisi potevano giungere, poi si è fermato. In fondo è stato onesto. E a suo modo ha amato l’Italia.
Ma il nostro autore avrebbe ancora scandalizzato il belpaese quando si occupò di Mussolini, attirandosi anche gli strali di De Felice e levandogli il monopolio del revisionismo. A leggere Le guerre del Duce (1976) e Mussolini (1982) c’è da divertirsi, se non fosse in realtà una tragedia nazionale. In sostanza, Mussolini era un opportunista ossessionato dal Potere, prigioniero della sua autoesaltazione, padrone dei mass-media dell’epoca, intelligente in politica ma autocratico e incompetente sul piano militare. Dati alla mano, Mack Smith dimostra che il Fascismo (“parola italiana per un’invenzione italiana”) ha sempre cercato la guerra ma non si è mai preparato per farla, coi risultati che sappiamo. Purtroppo Mack Smith non si è mai occupato di Berlusconi. Ha seguito amorevolmente la nostra storia fin dove la sua cultura e la sua capacità di analisi potevano giungere, poi si è fermato. In fondo è stato onesto. E a suo modo ha amato l’Italia. A capo del neonato partito anti-islamizzazione (PAI) c’è infatti uno psichiatra criminologo, Alessandro Meluzzi. La fondazione del suo partito è curiosamente simmetrica e contemporanea a quella del suo omologo, il futuro Partito islamico, che è perlomeno promosso da una persona accreditata: Roberto Hamza Piccardo, l’ex esponente
A capo del neonato partito anti-islamizzazione (PAI) c’è infatti uno psichiatra criminologo, Alessandro Meluzzi. La fondazione del suo partito è curiosamente simmetrica e contemporanea a quella del suo omologo, il futuro Partito islamico, che è perlomeno promosso da una persona accreditata: Roberto Hamza Piccardo, l’ex esponente  dell’Unione delle comunità islamiche italiane (Ucoii). Il 2 luglio, in via Maderna a Milano, si è riunita la Costituente islamica di cui Piccardo è segretario. Un’assemblea che, secondo l’ex esponente Ucoii, “vuole dare una rappresentanza democratica ai circa 2,6 milioni di musulmani italiani”. Chi pensava di guadagnar voti con l’approvazione dello Jus soli ha fatto male i calcoli: i gruppi etnici o religiosi si organizzano da soli, come del resto proprio in Italia insegna l’esempio della Sudtiroler Volkspartei.
dell’Unione delle comunità islamiche italiane (Ucoii). Il 2 luglio, in via Maderna a Milano, si è riunita la Costituente islamica di cui Piccardo è segretario. Un’assemblea che, secondo l’ex esponente Ucoii, “vuole dare una rappresentanza democratica ai circa 2,6 milioni di musulmani italiani”. Chi pensava di guadagnar voti con l’approvazione dello Jus soli ha fatto male i calcoli: i gruppi etnici o religiosi si organizzano da soli, come del resto proprio in Italia insegna l’esempio della Sudtiroler Volkspartei. A ottobre di quest’anno ricorre il centenario della più grande sconfitta militare rimasta nella memoria italiana, e il libro di Claudio Razeto cerca di fare il punto su una vicenda tuttora controversa. Lo fa in maniera molto chiara, seguendo gli avvenimenti dal 1916 al 1918 e oltre, corredando la narrazione con una scelta accurata di mappe e fotografie d’epoca. In questo l’autore è uno specialista, vista la sua esperienza di ricercatore di archivi storico-fotografici e il suo lavoro all’ANSA. La dodicesima battaglia dell’Isonzo – così gli Austriaci chiamano Caporetto – portò il nemico a occupare Veneto, Friuli e Carnia in pochi giorni, fino alla linea del Piave, dalla quale è partita la nostra riscossa finale. Il fronte italiano correva per 600 km lungo l’arco alpino, ottimo per difendersi ma non per attaccare. In più, il Trentino (austriaco) s’incuneava in modo tale da minacciare lo schieramento italiano tutto proteso a est. Per ben due volte – nel 1916 con la Battaglia degli Altopiani o Strafexpedition e nel 1918 con la Battaglia del Solstizio – l’Italia rischiò l’invasione dalle valli del nord. A est le vie d’accesso all’Impero Austro-Ungarico erano solo due: la via per Vienna, cioè il valico del Tarvisio (dove era passato Napoleone) e la via per Lubiana, ovvero Gorizia e le gole d’Isonzo. Trieste era invece naturalmente difesa dal Carso, un ampio, arido rilievo prossimo alla costa ma ben difendibile. Scartato stranamente il Tarvisio, Cadorna per due anni e mezzo attaccherà sistematicamente su due soli punti: verso la val d’Isonzo e verso Trieste. Direttrici obbligate: la valle dell’Isonzo scende parallela all’arco orientale delle Alpi e l’accesso per Gorizia passa per un’ampia gola scavata dal fiume tra due montagne, di fronte a Tolmino. La presa di Gorizia (1916) è l’unica conquista significativa: le undici battaglie dell’Isonzo, tutte combattute su due soli fulcri, portarono a guadagni di terreno minimi a fronte di perdite enormi. Trieste non fu mai presa e nell’alta val d’Isonzo – circondata dalle montagne – ci attestiamo già dal 1916 nel saliente fra Caporetto e Tolmino. Ed è dal luogo fisico che dobbiamo partire: Caporetto, Kobarid per gli Sloveni, è un villaggio che occupa un’ampia conca lungo la valle dell’Isonzo dalla parte slovena, all’incrocio fra il fiume e la piana del Friuli. Noi, incuneati nel saliente, potevamo al massimo prendere Tolmino e risalire la ferrovia sino a Lubiana, mentre il nemico, una volta sfondato il varco verso Gorizia, avrebbe visto aperta la piana del Veneto, costringendo l’intero schieramento italiano ad arretrare per tutto l’arco alpino. E questo è esattamente quanto avvenne il 24 ottobre del 1917.
A ottobre di quest’anno ricorre il centenario della più grande sconfitta militare rimasta nella memoria italiana, e il libro di Claudio Razeto cerca di fare il punto su una vicenda tuttora controversa. Lo fa in maniera molto chiara, seguendo gli avvenimenti dal 1916 al 1918 e oltre, corredando la narrazione con una scelta accurata di mappe e fotografie d’epoca. In questo l’autore è uno specialista, vista la sua esperienza di ricercatore di archivi storico-fotografici e il suo lavoro all’ANSA. La dodicesima battaglia dell’Isonzo – così gli Austriaci chiamano Caporetto – portò il nemico a occupare Veneto, Friuli e Carnia in pochi giorni, fino alla linea del Piave, dalla quale è partita la nostra riscossa finale. Il fronte italiano correva per 600 km lungo l’arco alpino, ottimo per difendersi ma non per attaccare. In più, il Trentino (austriaco) s’incuneava in modo tale da minacciare lo schieramento italiano tutto proteso a est. Per ben due volte – nel 1916 con la Battaglia degli Altopiani o Strafexpedition e nel 1918 con la Battaglia del Solstizio – l’Italia rischiò l’invasione dalle valli del nord. A est le vie d’accesso all’Impero Austro-Ungarico erano solo due: la via per Vienna, cioè il valico del Tarvisio (dove era passato Napoleone) e la via per Lubiana, ovvero Gorizia e le gole d’Isonzo. Trieste era invece naturalmente difesa dal Carso, un ampio, arido rilievo prossimo alla costa ma ben difendibile. Scartato stranamente il Tarvisio, Cadorna per due anni e mezzo attaccherà sistematicamente su due soli punti: verso la val d’Isonzo e verso Trieste. Direttrici obbligate: la valle dell’Isonzo scende parallela all’arco orientale delle Alpi e l’accesso per Gorizia passa per un’ampia gola scavata dal fiume tra due montagne, di fronte a Tolmino. La presa di Gorizia (1916) è l’unica conquista significativa: le undici battaglie dell’Isonzo, tutte combattute su due soli fulcri, portarono a guadagni di terreno minimi a fronte di perdite enormi. Trieste non fu mai presa e nell’alta val d’Isonzo – circondata dalle montagne – ci attestiamo già dal 1916 nel saliente fra Caporetto e Tolmino. Ed è dal luogo fisico che dobbiamo partire: Caporetto, Kobarid per gli Sloveni, è un villaggio che occupa un’ampia conca lungo la valle dell’Isonzo dalla parte slovena, all’incrocio fra il fiume e la piana del Friuli. Noi, incuneati nel saliente, potevamo al massimo prendere Tolmino e risalire la ferrovia sino a Lubiana, mentre il nemico, una volta sfondato il varco verso Gorizia, avrebbe visto aperta la piana del Veneto, costringendo l’intero schieramento italiano ad arretrare per tutto l’arco alpino. E questo è esattamente quanto avvenne il 24 ottobre del 1917.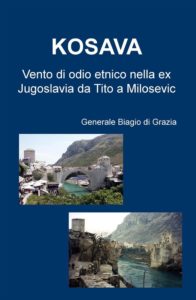 Kosava è il nome di un freddo vento balcanico che origina dai Carpazi e attraverso le Porte di Ferro dilaga fino all’Adriatico: metafora del male perverso che sconvolse l’allora Jugoslavia negli anni ’90 e che ora abbiamo rimosso, anche se da anni manteniamo truppe in Kosovo e la ricostruzione civile in Bosnia non è mai realmente avvenuta.
Kosava è il nome di un freddo vento balcanico che origina dai Carpazi e attraverso le Porte di Ferro dilaga fino all’Adriatico: metafora del male perverso che sconvolse l’allora Jugoslavia negli anni ’90 e che ora abbiamo rimosso, anche se da anni manteniamo truppe in Kosovo e la ricostruzione civile in Bosnia non è mai realmente avvenuta.