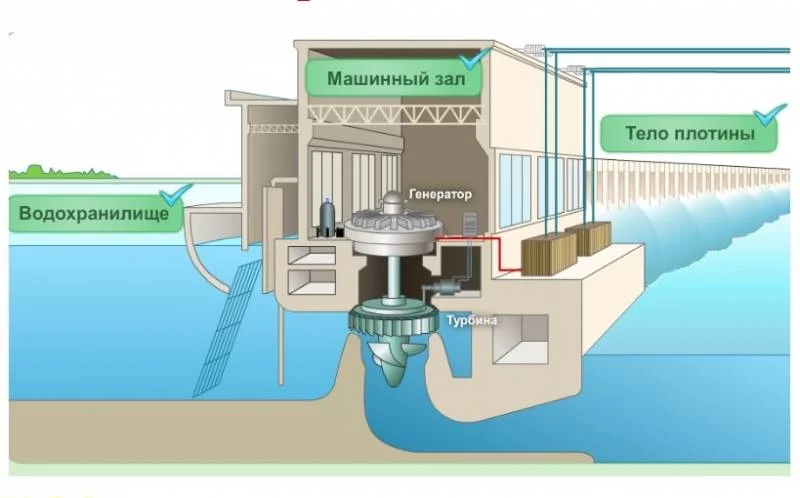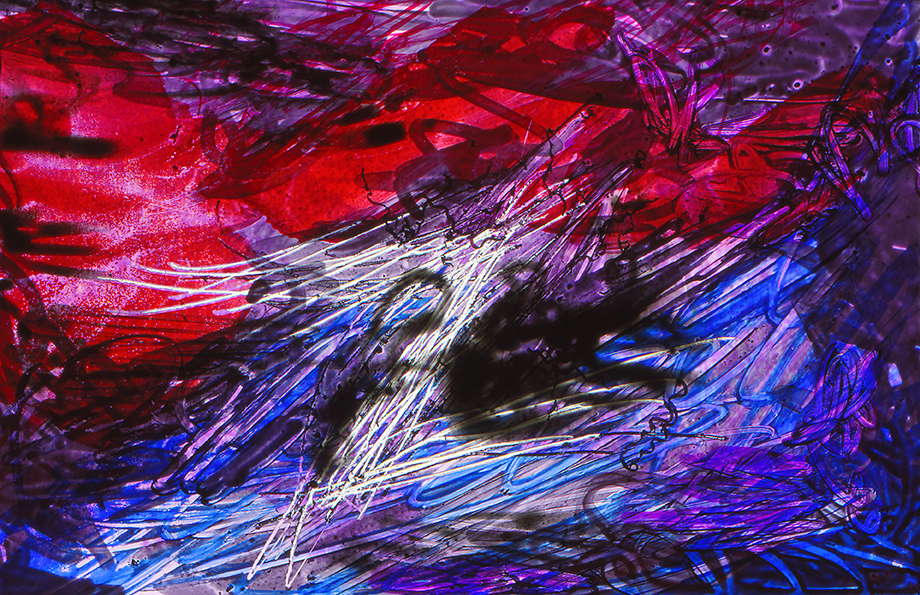L’anno che si è appena chiuso sarà ricordato come il peggiore di quelli recenti: alla guerra in Ucraina iniziata nel febbraio del 2022 si è aggiunta nell’ottobre 2023 quella fra Hamas e Israele. Due guerre molto diverse tra di loro, una fra nazioni e l’altra fra una nazione e un gruppo terroristico difficilmente inquadrabile in un’ottica tradizionale: Hamas: per la sua capacità organizzativa e logistica, per il raggio di azione delle operazioni militari del 7 ottobre e per il supporto che riceve da alcuni stati esterni alla Palestina non è inquadrabile come gruppo terroristico di capacità e obiettivi limitati. Piuttosto è l’esercito di uno stato nello stato. In più c’è l’appoggio di Hezbollah dal Libano e degli Houthi dallo Yemen. I primi per ora conducono azioni di disturbo dal sud del Libano, gli altri cercano di disturbare o impedire il traffico navale nel Mar Rosso, per ora contrastati da alcune navi da guerra francesi, inglesi e statunitensi: è impensabile che qualcuno si permetta di sabotare il 12% del traffico merci navale mondiale senza essere prima o poi preso a cannonate.
Un’altra osservazione: tutti sono rimasti sorpresi dalle due impreviste operazioni militari. Ebbene, mi permetto di dire che a guardar bene, l’aggressione russa all’Ucraina e il conflitto fra Hamas e Israele, pur avendo colto di sorpresa gli analisti, rientrano in una continuità storica prevedibile: l’Unione Sovietica / Russia ha sempre impedito con la forza l’attrazione delle nazioni vicine per l’Occidente, mentre Israele è da sempre in guerra con chi vuole distruggerlo. Nel primo caso in quasi cento anni ne hanno fatto le spese i Paesi Baltici, l’Ucraina, la Polonia, la Germania Est, l’Ungheria e la Cecoslovacchia, praticamente tutti tranne la Bulgaria e la Romania (anche se per motivi diversi). Occupare la capitale altrui per impiantare un proprio governo di fiducia ha funzionato per anni a Berlino, a Budapest, a Varsavia e a Praga, e nei piani di Putin avrebbe funzionato anche nell’Ucraina di Zelensky. Il passaggio dall’Unione Sovietica alla Russia di Putin non ha rotto la continuità di una politica estera, almeno una volta ripreso saldamente il timone del potere. Per certo si è sottovalutata la capacità russa di riprendere in mano una situazione di egemonia, ma non si credeva possibile una guerra ad alta intensità in Europa. Era un calcolo sbagliato ma razionale: almeno sul breve periodo, una guerra costa più di quanto puoi guadagnare sul terreno e la globalizzazione del commercio. Si è persino arrivati al paradosso di aggirare l’embargo da una parte e l’altra semplicemente perché l’economia non può fermarsi. Nulla di nuovo: nel ‘600 Spagnoli e Olandesi si facevano la guerra nelle Fiandre ma lasciavano aperto il commercio navale con cui finanziavano i propri eserciti. Anche Venezia e l’Impero Ottomano non bloccavano mai del tutto il traffico navale pur essendo spesso in conflitto aperto.
La guerra in Ucraina ha invece tutti i carismi della guerra classica, del conflitto ad alta intensità, della guerra lampo impantanata in trincee che mio nonno troverebbe familiari. Tipica “Materialschlacht”, attrito di materiali, dove vincerà chi avrà ancora qualcosa da mandare al fronte, sia mezzi materiali che soldati addestrati, ma è verosimile che si verrà a un armistizio: la guerra ha un costo che alla lunga è difficile sopportare per tutti. Ogni giorno si sono scambiati 5000 colpi di artiglieria e tra morti e feriti è verosimile calcolare 300.000 perdite per parte. Una guerra di posizione è come la prima guerra mondiale e come tale finisce per esaurimento di uno dei contendenti o per lo sfaldamento delle alleanze. Ma almeno finirà perché gli obiettivi sono limitati e razionali, mentre il conflitto fra Israele e Hamas con i Palestinesi in mezzo sa il cielo dove porterà: nessuno dei due contendenti è disposto a limitare i propri obiettivi e il conflitto potrebbe allargarsi in modo imprevisto. Difficilmente p.es. si permetterà alle batterie di missili dei ribelli Houthi di disturbare o interrompere il traffico navale nel Mar Rosso, dove passa il 20% di quello che arriva in Europa. Quanto alle Nazioni Unite, si è visto quanto valgono.
Ora qualche osservazione. Lo scopo di una guerra è impadronirsi delle risorse di un altro stato o nazione. L’ideologia crea una giustificazione emotiva più che razionale,, ma alla base le motivazioni sono sempre economiche. Se le guerre non sono frequenti (almeno in Europa) è perché nell’analisi costi-benefici condurre una guerra comporta spese maggiori di quanto si può guadagnare sul campo. La guerra è la continuazione del processo politico con altri mezzi (cito Karl von Clausewitz, un classico), ma altri mezzi possono appunto conseguire gli stessi obiettivi in modo più economico. Questo lo pensavamo ancora due anni fa, ora dovremo rivedere meglio i nostri parametri e le nostre sclerotizzate abitudini mentali