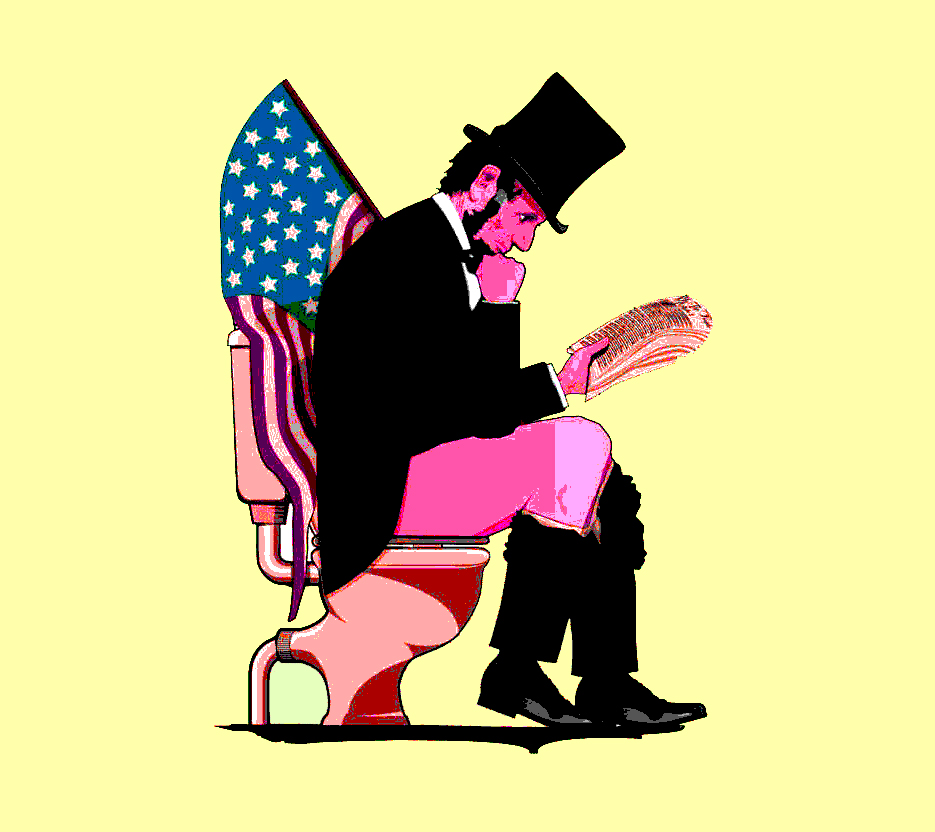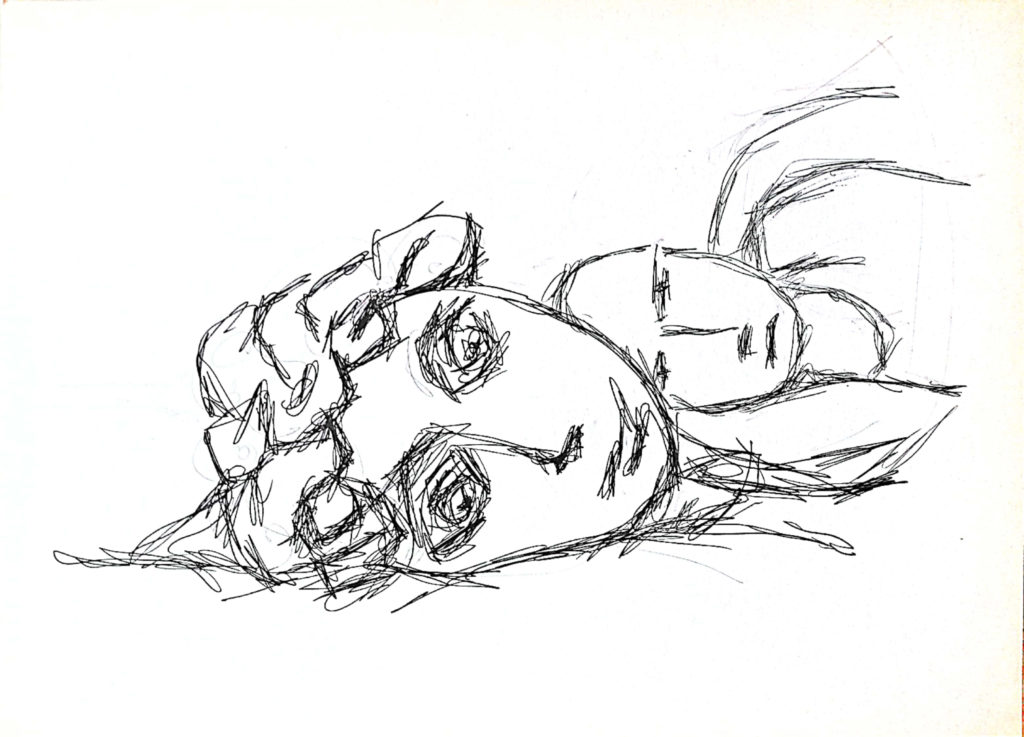I Francesi sono stati estromessi dal Mali; persino l’ambasciatore è stato cacciato e d’ora in poi la lingua ufficiale del Mali sarà soltanto il Bambara, parlata da circa due milioni e mezzo di abitanti ma facilmente compresa da altri tre. Non sappiamo se sarà anche abolita la valuta CFA (Franco centro-africano), diffuso nell’Africa francofona: vale un decimo del Franco francese ma è ancorato alla Banca di Francia. In ogni caso il posto dei soldati francesi sarà occupato da almeno 500 miliziani del Gruppo Wagner, quella specie di Legione Straniera russa già presente in Libia e forse ora anche in Ucraina. Quale sia il loro reale valore sul campo piuttosto che come pretoriani di regime è tutto da verificare, ma per la Francia di Macron è uno smacco: il Mali, come il Burkina Faso, era parte delle colonie africane e come tale manteneva forti legami politici e commerciali con la sua antica potenza di riferimento. Nel contratto di assistenza al locale governo era prevista la protezione militare contro attacchi esterni, in questo caso i guerriglieri Jahidisti che premono dal nord del paese. Per chi non conoscesse il Mali consiglio di dare un’occhiata alla carta geografica: è il classico stato africano disegnato con squadra e compasso in maniera assolutamente irrazionale: la parte a sud dei fiumi Niger e Senegal gravita sulla savana ed è la più popolata e coltivata, mentre la parte nord è un’enorme parte del Sahara sagomata geometricamente; è abitata da nomadi Tuareg ed è ricca di risorse minerarie. Ma difficile parlare di confini, di frontiere difendibili: il Mali è per molti versi un’astrazione geografica, come anche altri stati africani derivati dalla decolonizzazione. E come tanti stati africani, non riesce ad avere una dirigenza adeguata alla situazione. Quella attuale, capeggiata da Assimi Goïta, non fa eccezione.
Ora, sono stati fatti facili confronti fra la disfatta statunitense in Afghanistan e quella francese in Mali, ma la realtà è diversa: l’esercito francese, coadiuvato dalla ben nota Legione Straniera, conosceva da oltre un secolo il terreno e nel corso del tempo aveva ottenuto anche reali successi militari, pur penalizzati dalla vastità del territorio e soprattutto da problemi politici nel rapporto con il governo del Mali. In regime coloniale la potenza occupante gestisce direttamente tutto, laddove ora può solo garantire assistenza alle fragili strutture statuali e ai deboli eserciti delle sue ex-colonie. Di fronte a una minaccia strutturale dovuta essenzialmente a una scarsa coesione sociale e statuale, addestrare le truppe locali non basta e in più un’eccessiva ingerenza esterna da parte di una ex-potenza coloniale viene malvista dalla gente. Esattamente quello che è successo in Mali.
Ma andiamo per ordine: dopo il colpo di stato del 2012 di soldati ammutinati guidati dal capitano Amadou Haya Sanogo e la sospensione della Costituzione, dall’aprile 2012 all’agosto 2013 è presidente ad interim Dioncounda Traoré, designato dalla giunta militare, e Cheick Modibo Diarra Primo Ministro ad interim il 17 aprile 2012 per aiutare il processo democratico fino alle elezioni del dicembre 2013. Nel frattempo riprende la guerra civile che ha portato l’etnia Tuareg (laica) del Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad, ad allearsi con alcune frazioni fondamentaliste, (gli Ansar Dine) che aderiscono al Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento, alias al-Qa’ida nel Maghreb islamico, e a prendere il controllo della regione settentrionale del Paese, l’Azawad, regione che comunque nulla ha che spartire con la parte del Mali a sud dei grandi fiumi. Il 10 gennaio 2013 il presidente Dioncounda Traoré‚ in un discorso alla nazione, comunica di aver chiesto e ottenuto un intervento aereo della Francia, in accordo con l’Ecowas, la comunità economica dei paesi dell’Africa occidentale, contro i ribelli dell’Azawad (il nord del Paese). L’intervento francese in effetti libera i centri abitati dell’’Azawad cadute in mano ai fondamentalisti islamici, dove le truppe sono accolte con esultanza dalla popolazione. Nei quasi dieci anni successivi la guerriglia continua e i francesi contano alla fine 53 perdite, quante noi italiani in dieci anni in Afghanistan. Senonché il 18 agosto 2020 il presidente Ibrahim Boubacar Keïta assieme al primo ministro vengono tratti in arresto mediante colpo di Stato di una giunta militare. Prende il potere il Comitato nazionale per la salvezza del popolo che nomina il triumvirato Assimi Goïta, Malick Diaw e Sadio Camara fino a nuove elezioni politiche. Goita ha studiato a Mosca, parla russo e sobilla l’ostilità verso i francesi, i quali comunque da giugno di quest’anno avevano deciso di ridurre il loro impegno militare per il costo rispetto ai benefici, portando il proprio contingente da 5000 a 2000 uomini. A meno di non ricolonizzare l’Africa da capo, questo è un problema che assilla tutti gli eserciti occidentali. Ma soprattutto rimane il problema registrato in Afghanistan: non si può gestire una strategia di lungo termine con le risorse locali e i chiari di luna dei colpi di Stato e dei gruppi dirigenti locali, i quali alla fine sono capaci di venire a patti col nemico pur di salvare almeno parte del potere e del territorio. Solo negli ultimi dieci anni l’Africa ha visto una dozzina di colpi di Stato. In più gli eserciti europei alla fine se ne vanno, mentre il nemico è endemico e abita nel paese tuo, quindi meglio parlarci. Quanto a Russi e Cinesi, chiedono la licenza di estrazione delle risorse minerali, ma sono disposti ad aiutarti senza chiederti quelle noiosissime clausole che comprendono un parlamento eletto, l’indipendenza della magistratura, la libertà di stampa e il rispetto dei diritti umani. Ma alla fine per gli africani significa passare solo da una potenza post-coloniale all’altra.