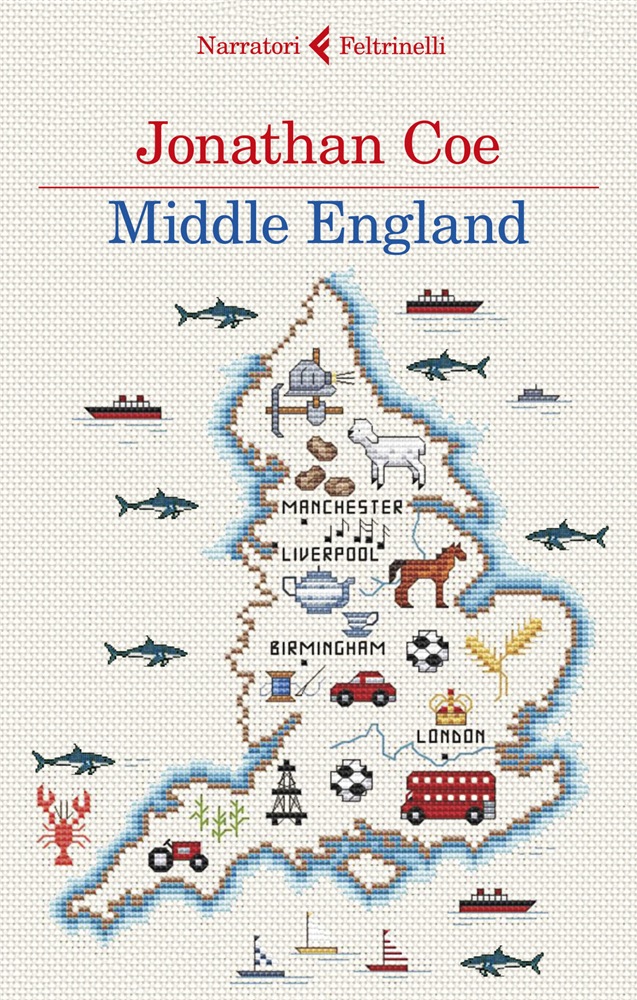Sono meno di cento pagine, ma preziose: poco o nulla esisteva in argomento, né è stato facile recuperare e mettere insieme una congerie di opuscoli e documenti non tutti registrati dalla Biblioteca Nazionale, stampati con tirature ineguali da collettivi o piccoli editori, pochi dei quali sono rimasti attivi nel lungo periodo. Fa eccezione Stampa Alternativa, che festeggia i suoi primi cinquant’anni di attività e vanta una produzione sterminata tra libri, libelli e quant’altro. E qui va chiarito un concetto: la pirateria editoriale non perseguiva fini commerciali, ma democratici: culturali e politici. Lo stesso vale per i falsi: erano provocazioni che nulla hanno a che spartire con quei prodotti che sfruttano un nome o un marchio famoso per fare quattrini senza pagare i diritti. Ricordo p.es. copie pirata di Love Story e addirittura de Le nozze di Cadmo e Armonia di Piero Citati: quelle 80 pagine erano state rifatte da una tipografia e solo l’occhio del bibliotecario notava le inesattezze sfuggite al cliente di libreria. E girano da sempre edizioni fantasma di Mein Kampf, stampate senza registrazione ma da sempre popolari in certi ambienti. Va detto invece che le indicazioni di stampa che dovevano tutelare i pirati politici sono le più varie: Amsterdam o Londra, con tanto di indirizzo e sigla di fantasia, oppure supplemento di Stampa Alternativa (con la benedizione della testata registrata). Fantomatiche le Edizioni Vuoto a Perdere, altrettanto misteriose le Edizioni del Sole Nero, mentre in una pubblicazione pirata si legge addirittura: stampato a Magonza, presso Gutemberg!
Ma torniamo ai contenuti. Si stampavano essenzialmente opere che ancora non erano state tradotte – testi teorici innanzitutto – o che avevano un costo proibitivo per lo studente. Per abbassare i costi si ricorreva a carta comune, margini stretti, caratteri ridotti e soprattutto distribuzione alternativa, il che significava far arrivare la cultura in luoghi e ambienti fino allora tagliati fuori dalla distribuzione ufficiale. Né si creda che fossero sottoprodotti: la traduzione de La società dello spettacolo di Guy Debord risulta migliore nell’edizione pirata che in quella ufficiale di De Donato (1968). L’edizione a cura de L’Erba Voglio dei Minima moralia di Adorno del 1976 rende giustizia a quella pubblicata da Einaudi nel 1954, molto lacunosa; al punto che l’Einaudi stesso la ristampò integrale nel 1979, concedendo sottobanco ai pirati di esaurire le scorte. Ma l’elenco di opere stampate o tradotte o ristampate senza autorizzazione né royalties è lunga quanto interessante: i libelli femministi stampati da Limenetimena, le edizioni di Anarchismo, poesie e canzoni di Patti Smith, alcuni manuali sudamericani di guerriglia, Céline, Bataille, Evola; alcune opere di Wilhelm Reich su politica e sessualità, già pubblicate su riviste professionali difficilmente accessibili ai più; le opere situazioniste di Raoul Veigenem; La politica dello stupro di Diana E.H. Russell, il famoso S.C.U.M di Valerie Solanas, La morte della famiglia di David Cooper, più opere di Louis-André Salomé, di Gilles Deleuze e Felix Guattari, Michel Foucault, Aldous Huxley… insomma, una bella biblioteca, anche se non rilegata in pelle. Ed è grazie a queste edizioni che molti di noi sono cresciuti culturalmente e politicamente. Stampare senza permesso o rifiutando la SIAE è stata una scelta produttiva e politica di cui oggi sinceramente si sente la mancanza, anche se la Rete ha creato nuovi spazi alla diffusione della cultura.
Parlavamo anche dei falsi. Siamo così abituati al falsario geniale ma venale, da non pensare alle provocazioni dei surrealisti, dei dadaisti, degli anarchici, dei situazionisti. Chi scrive ricorda le false prime pagine dei quotidiani edite da il Male, paradossale esempio di manierismo e satira insieme. Ma sono rimasti nella storia ben altri falsi: l mio testamento politico di Sartre (1978), scritto dagli anarchici di Catania, e soprattutto il Rapporto veridico sulle ultime opportunità di salvare il capitalismo in Italia (1975), scritto da “Censor” (in realtà Gianfranco Sanguinetti). Inviato volutamente nei circoli che contano, fu preso per buono da tutti e proponeva una soluzione per evitare il comunismo estremo e riformare il capitalismo dall’interno. Non doveva essere uno studio teorico superficiale, se fu apprezzato da sindacalisti, industriali e giornalisti, i quali furono poi pubblicamente diciamo “derisi” quando l’autore uscì allo scoperto. Altro capolavoro furono le Lettere agli eretici di Enrico Berlinguer (1977). La veste editoriale ricopiava il format della collana Nuovo Politecnico della Einaudi, per cui approdò in libreria sotto mentite spoglie. Le lettere sono indirizzate a Marco Pannella, Goffredo Fofi, Adele Faccio, Angelo Pezzana, Renato Curcio, Andrea Valcarenghi, Toni Negri. L’ultima lettera è per gli Indiani Metropolitani, considerati collettivamente. Il falso è persino grossolano, ma ci cascarono in parecchi. Autore ne era Pierfranco Ghisleni, il quale rispose a tono a Giulio Bollati, direttore commerciale di Einaudi, accusandolo di non aver capito il senso culturale dell’operazione. Ovviamente il libro fu sequestrato e ora è merce di antiquariato. La cosa buffa è che due di queste lettere apocrife furono ristampate… da un’edizione pirata di Verbania. Nel 1982 Ghisleni diviene direttore del Male, che già dal 1978 si faceva notare per le sue trovate. Nel frattempo il suo editore aveva stampato Esortazione alla Democrazia Cristiana affinché lasci il governo in Italia e passi all’opposizione, scritto da un certo Antoine A. de Toqueville, allusione al grande teorico francese della democrazia. Ma interessante fu il commento di Umberto Eco al falso Sartre (1978): “Negli ultimi due anni: manifesti politici del gruppo A con la firma del gruppo B; il falso epistolario di Berlinguer (…) il falso testo di Sartre (…) Ce ne accorgiamo ancora perché le falsificazioni sono grossolane e tutto sommato inabili o troppo paradossali. Ma se tutto fosse stato fatto meglio e con un ritmo più intenso? Non resterebbe che reagire alle falsificazioni con altre falsificazioni (…) ma proprio questo sospetto mostra il potenziale suicida contenuto nelle tecniche falsificatorie”. Dopo 40 anni, nell’era dell’Internet e delle fake news, che dire?
In appendice, una specie d’intervista al pirata per eccellenza, Marcello Baraghini, fondatore di Stampa Alternativa.
Pirati e falsi editoriali nell’Italia degli anni ’70
di Duccio Dogheria
Edizioni: Le Strade Bianche di Stampa Alternativa, 2018