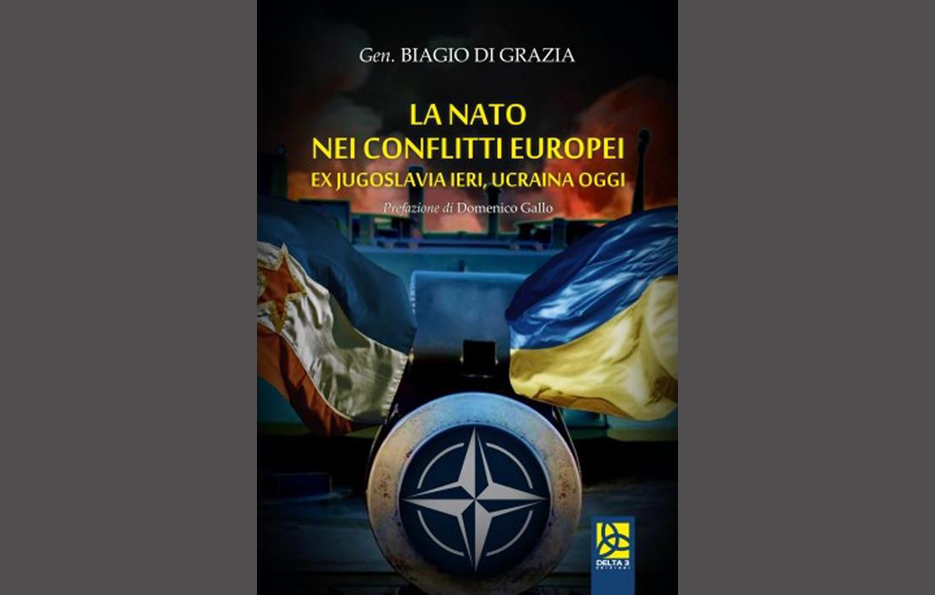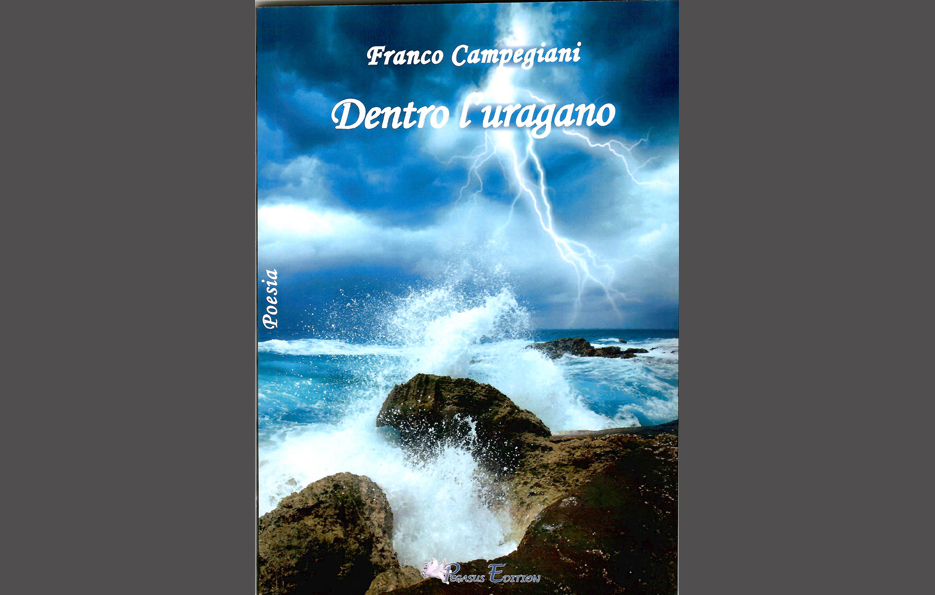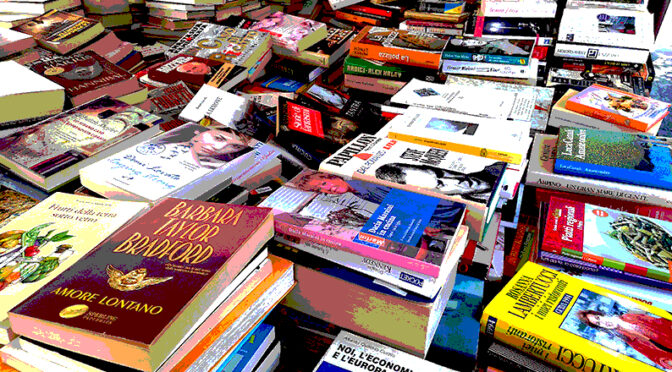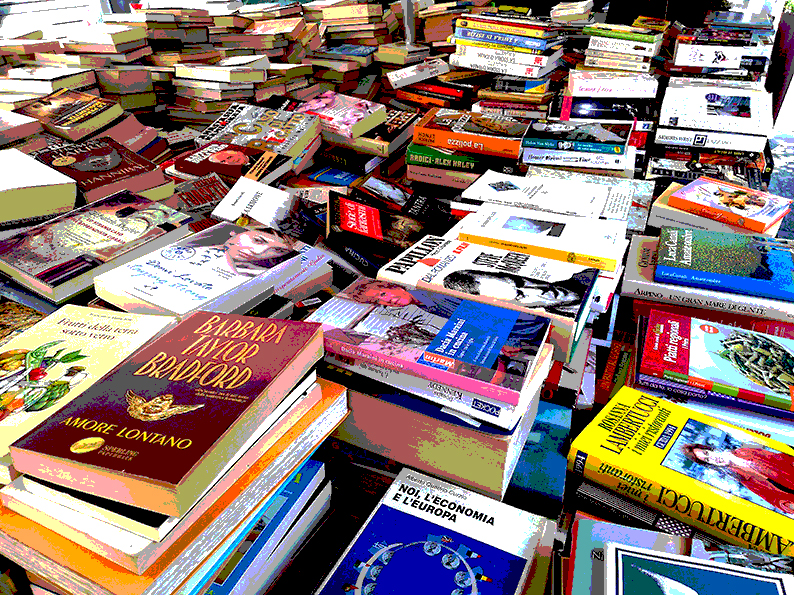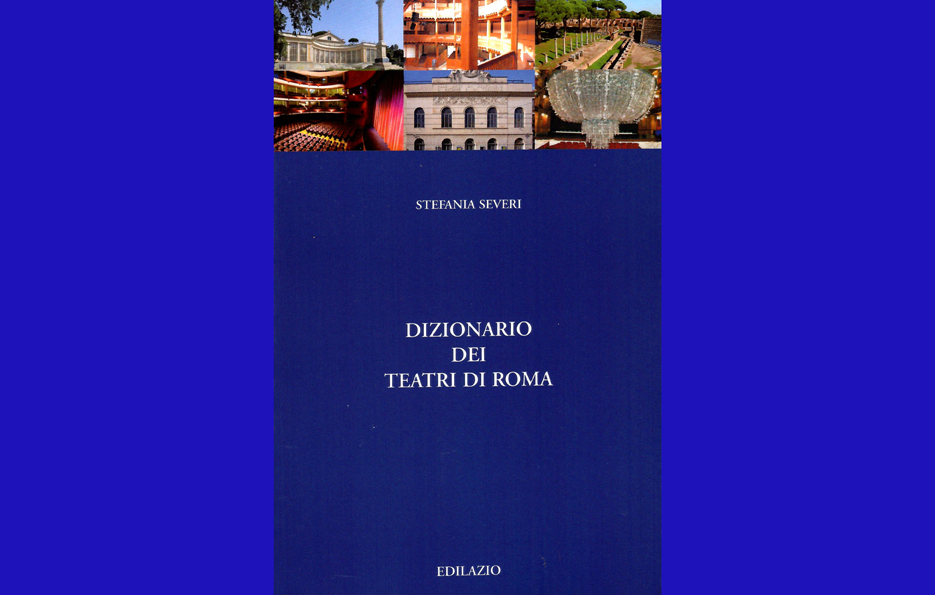
Lo scarno titolo non rende appieno la ricchezza del libro, il quale è diviso in due parti ben distinte: la storia del teatro a Roma, inteso sia come struttura fisica che come espressione artistica, e uno schedario sistematico, esauriente e aggiornato di schede dei singoli teatri. La prima parte è organizzata in ordine cronologico, la seconda è divisa per ordine alfabetico e completata da un indice analitico. L’autrice è già nota come artista e curatrice di mostre (1) e per una serie di monografie di arte e altro, tra cui citiamo: I mosaici a Roma dall’antichità al Medioevo, Santa Maria in Montesanto, Il vino a Roma e nel Lazio, Sciamè. Alchimia del rosso, Il canto della terra, L’ essenza della solitudine, Dolores Prato, Vostra Veronica. In questo libro appena uscito Stefania Severi ripercorre non solo la storia degli edifici teatrali dall’antica Roma a oggi, ma anche degli autori, artisti, impresari e promotori che hanno reso possibile una continuità culturale che supera i duemila anni. E naturalmente si parla anche del pubblico, il vero protagonista delle fortune e sfortune della scena romana, dove la storia del teatro presenta caratteristiche uniche: da un lato c’è l’origine sacrale dello spettacolo – pagana o cristiana non importa – e dall’altro la coesistenza da sempre di espressioni di cultura alta insieme a spettacoli plebei, popolari, con curiose ibridazioni fra i due registri – sarcasticamente commentati nei sonetti del Belli – dovute alla particolare struttura sociale romana: la Chiesa condizionava la durata della stagione teatrale (iniziava a dicembre, ma per la Quaresima i teatri erano chiusi) ma promuoveva le sacre rappresentazioni e lasciava una certa libertà al teatro popolare o aulico che fosse, purché non si discutesse di politica o di religione. Ma nei teatri come nei palazzi convivevano, sia pur in settori diversi, nobili e plebei, borghesi e “generone”, senza quella separazione di casta presente in altre società anche italiane. I viaggiatori stranieri notavano da un lato la grande passione dei romani per il teatro a tutti i livelli, ma dall’esterno vedevano i romani come parte stessa dello spettacolo, fosse per la prima di un’opera lirica o per una processione della Settimana Santa (2). Nell’antica Roma il pubblico non pagava (panem et circenses..) e i teatri col tempo erano divenuti monumentali. Il teatro di Ostia antica ancora è attivo, gli altri – teatro di Pompeo, di Marcello, di Traiano – restano monumenti a memoria di fasti passati. Il medioevo vede sacre rappresentazioni, cerimonie, cortei e processioni registrate da precisi cronisti e cerimonieri come il Burcardo, ma col Rinascimento e il Barocco rinasce il teatro laico, patrocinato dalle famiglie nobili, le quali inseriscono fino a due secoli dopo un teatro privato nei loro palazzi, mentre ben presto l’iniziativa privata si adegua alla domanda e diversifica l’offerta, che va dal dramma e melodramma alla commedia, dall’aulico alla farsa popolare, dal teatro di parola al mimo e ai burattini. Giustamente l’autrice parla in questo senso di “sistema teatrale”, data la quantità e la diversificazione dell’offerta romana, col suo ampio spazio per nobili mecenati e impresari privati, attori e cantanti professionisti e confraternite di dilettanti, primedonne, gigioni, musicisti, artisti di scena e artigiani. Alla fine di ogni secolo è riportato l’elenco dei singoli teatri con la data di apertura. Se manca l’asterisco la struttura è ancora aperta alla scena. Se l’Apollo non esiste più, alcuni sono ancora in attività, magari con repertorio diverso. Penso al teatrino di palazzo Altemps, al teatro Argentina ora di prosa ma nato lirico (vide la prima del Barbiere di Siviglia), ma anche all’Oratorio del Borromini. Pur nella relativa stasi dello Stato Pontificio, la vita teatrale romana ha sempre avuto un grande impulso creativo e una grande popolarità
La cesura tra due epoche avviene quando nel 1870 Roma diviene capitale d’Italia, con la rapida trasformazione urbanistica e sociale delle sue strutture e del pubblico. Risale alla seconda metà del XIX secolo la costruzione di nuovi teatri. La gran parte dei teatri di fine secolo è attiva: il Costanzi per l’Opera, il Quirino, l’Eliseo, la Sala Umberto, il Salone Margherita, l’Ambra Jovinelli, tanto per citarne alcuni. Carente è invece il secondo dopoguerra, che ha visto solo ristrutturazioni e riconversioni spesso discutibili (la distruzione dell’Adriano per farne una multisala è emblematica) e soprattutto ha penalizzato la periferia continuando a concentrare lo spettacolo al centro storico, a parte gli introvabili teatri tenda. Ma dagli anni 60 ci immergiamo in nella realtà più difficile da schedare: l’esplosione del teatro sperimentale e dei “teatrini” – talvolta scantinati o locali recuperati – che renderanno Roma una delle città più vivaci d’Italia. “Uno, cento, mille teatrini” è più di uno slogan. Concentrati fra Trastevere e Testaccio ma non solo, pur in autentica povertà di mezzi diventano un mondo parallelo che per osmosi trasmette al Teatro Stabile nuovi linguaggi e rinnova un repertorio all’epoca fin troppo alimentato dagli abbonamenti del pubblico borghese. Ripercorrere con la Severi le vicende dell’avanguardia teatrale romana è divertente quanto difficile, ogni segmento essendo originale e non sempre documentabile con precisione. Non era il mondo dell’Effimero dell’assessore Nicolini – grande rinnovatore della periferia e inventore dell’estate Romana – ma ne ha preparato il terreno.
E il nuovo secolo come si presenta? Da un lato Roma con l’Auditorium Parco della Musica di Renzo Piano (2001) ha finalmente uno spazio adeguato a un capitale europea e l’offerta teatrale si è decentrata anche in zone prima culturalmente deserte, vuoi per intervento pubblico (Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Corviale, circuito TIC, Teatri in Comune) che privato (Teatro degli Audaci, Il Globo fondato da Proietti), mentre i “teatrini”, decimati dalle nuove leggi di sicurezza e dall’età dei fondatori, sopravvivono o passano il testimone ai loro allievi, visto che proliferano le scuole di teatro a tutti i livelli. Passato il Covid, in questo momento il teatro non è in declino, a differenza delle sale cinematografiche che chiudono. Il motivo? C’è il desiderio naturale di vedere fisicamente l’attore e lo spettacolo dal vivo è un salutare antidoto all’inflazione da immagini registrate e/o scaricabili.
Addenda: per contenere il prezzo (22 euro per 327 pagine) il libro è privo di illustrazioni. Per integrarne la lettura consiglio un sito completo di immagini, schede e indicazioni topografiche: https://www.info.roma.it/teatri_di_roma.asp
Note:
- https://www.exibart.com/artista-curatore-critico-arte/stefania-severi/
- Vedi p.es. Città teatrale. Lo spettacolo a Roma nelle impressioni dei viaggiatori americani 1760-1870, di Alessandro Gebbia, 1985.
Dizionario dei teatri di Roma
Stefania Severi
Edilazio, Roma, 2023. pp.327
Prezzo 22,00 euro