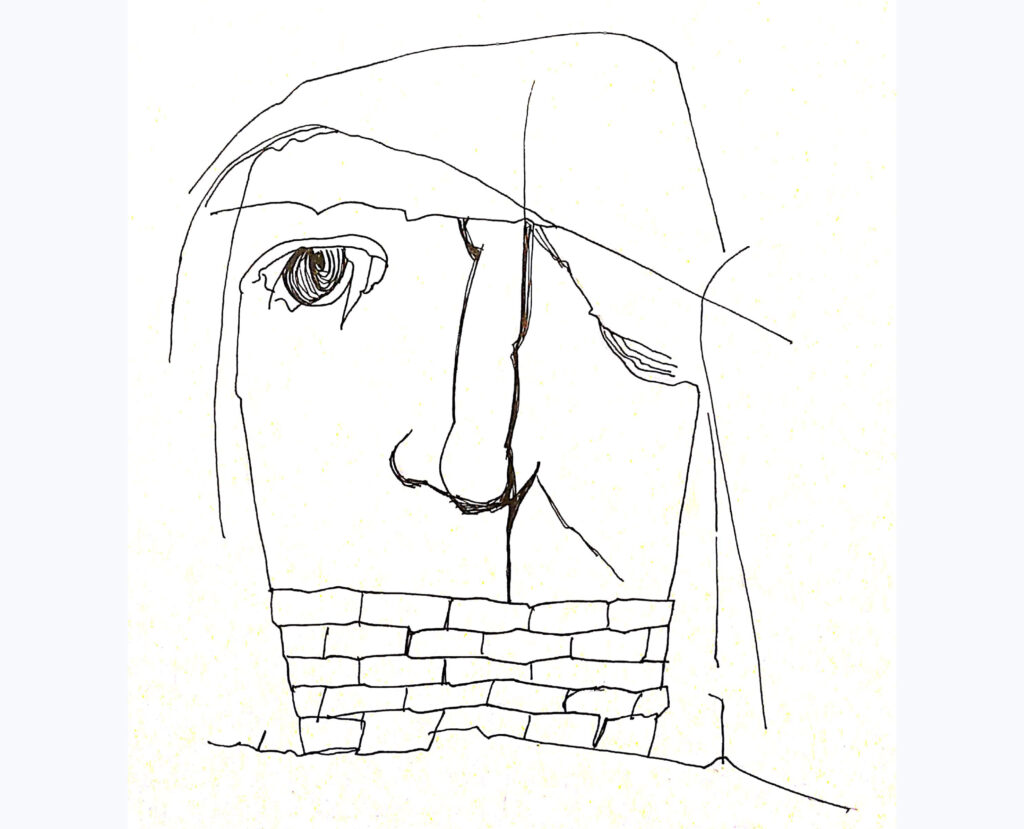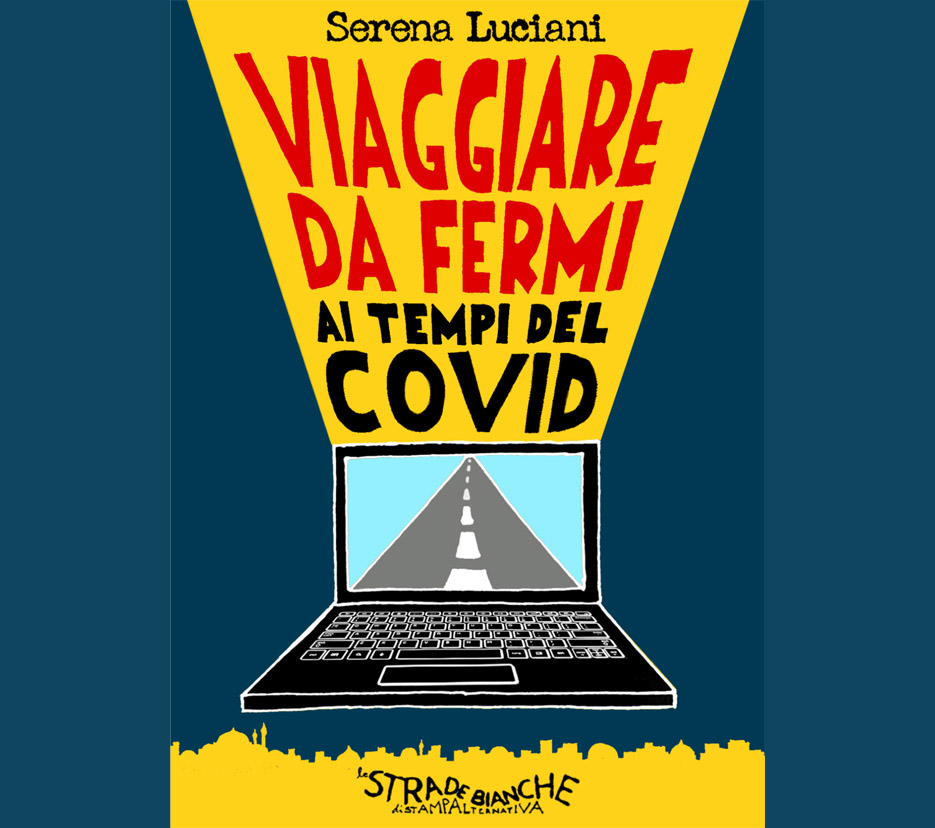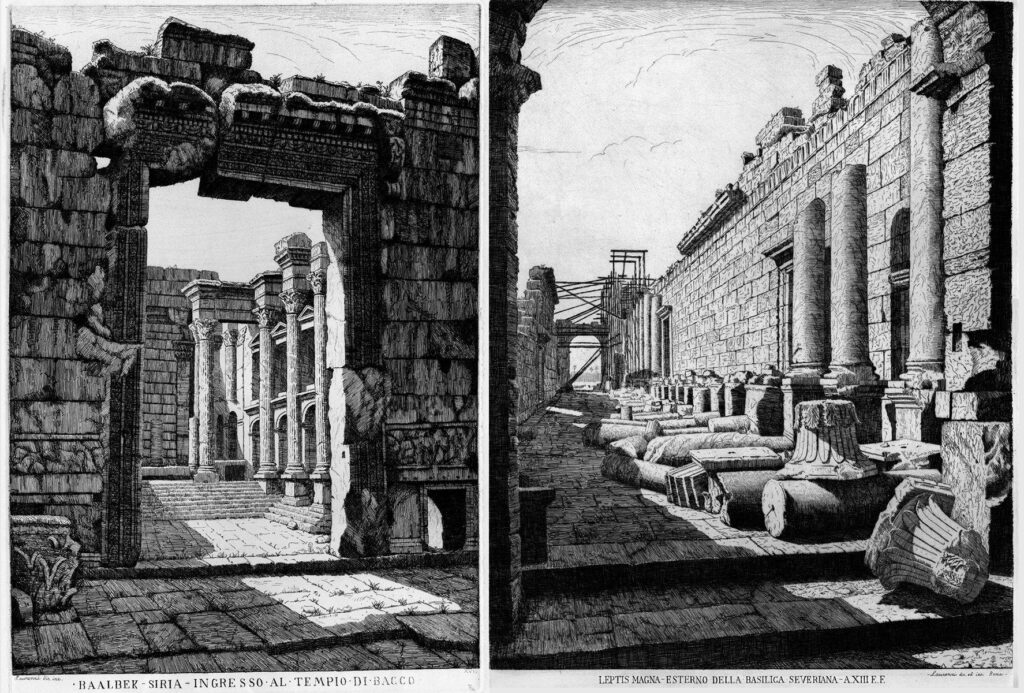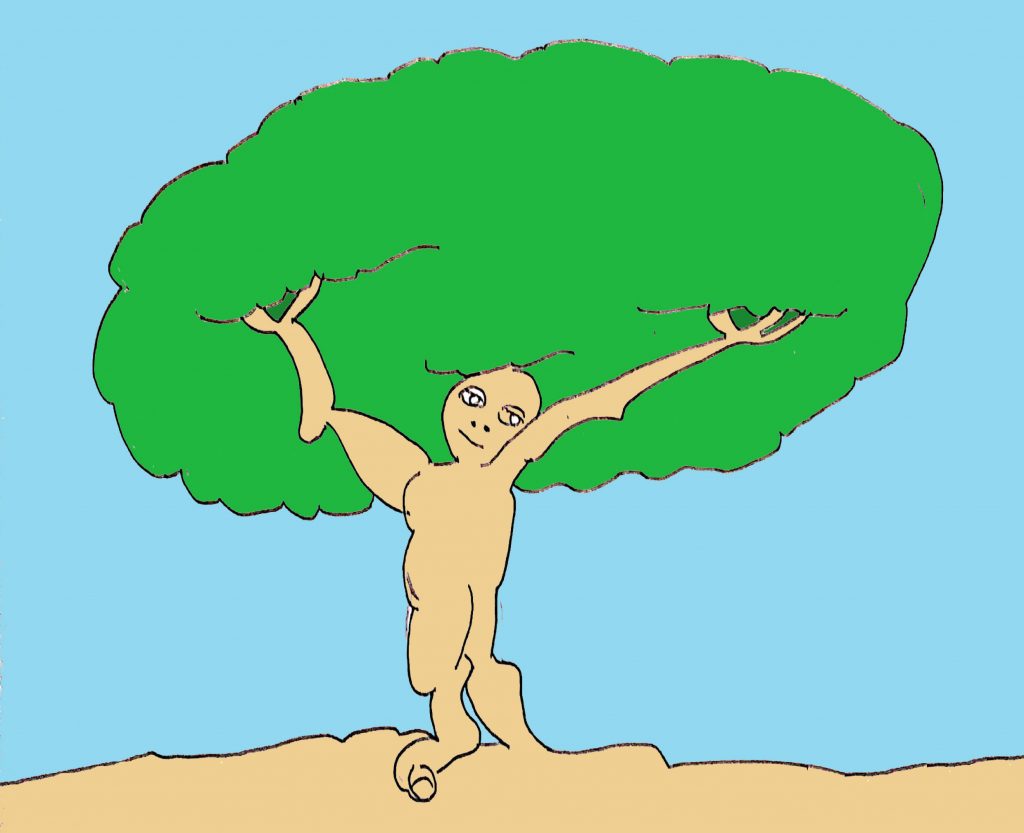
Cito da Varrone, De Re Rustica, I.28
Hoc ter noviens cantare iubet, terram tangere, despuere, ieiunum cantare. Multa, inquam, item alia miracula apud Sasernas invenies, quae omnia sunt diversa ab agri cultura et ideo repudianda. Quasi vero, inquit, non apud ceteros quoque scriptores talia reperiantur.
“Prescrive di cantare nove volte per tre volte, toccar terra, sputare, cantare a digiuno. Di questi ‘miracoli’ ne troverai molti altri se segui i Saserna, cosa ben diversa dall’agricolura e per questo da non accettare. Quasi sicuramente questa roba non la troveresti in altri scrittori”.
Varrone scrisse duemila anni fa un buon manuale di agricoltura (il De re rustica, appunto), sulle orme di un analogo trattato di Catone il vecchio, mentre i Saserna (padre e figlio) ne avevano scritto un altro (perduto, ma citato anche da Columella, altro agrario) dove, da buoni etruschi, davano ampio spazio anche a pratiche magiche che il razionalista Varrone rimanda al mittente. Ed ora, dopo duemila anni, al Senato c’è voluta l’opposizione della senatrice a vita Elena Cattaneo per aprire gli occhi sulla differenza tra agricoltura biologica e agricoltura biodinamica, allegramente omologate da una maggioranza assoluta di senatori non è chiaro se ingenui o disinformati. Equiparare i due metodi è poco scientifico, semplicemente perché l’agricoltura biodinamica si basa su presupposti scientificamente non misurabili con il metodo sperimentale di Galileo. Non solo: fermo restando il presupposto che numerosi prodotti biodinamici siano anche biologici, oggi questo prerequisito è venuto a mancare nel momento in cui operano nuove ditte oltre quella storica, la centenaria germanica Demeter, la quale finora ha garantito la qualità dei suoi prodotti. Quello che è da notare è che siccome alla Demeter sono affiliati alcuni produttori sudtirolesi, nella stampa locale è attiva una sorta di lobby a difesa di un prodotto culturalmente germanico (1). In effetti Rudolf Steiner, affascinante quanto bizzarra figura di filosofo, mistico, scrittore, pedagogista nonché fondatore anche dell’agricoltura biodinamica, è sicuramente più popolare nei paesi di cultura tedesca, e le sue scuole “Metodo Waldorf” da noi sono frequentate solo da un’élite benestante. Sia chiaro che uno è libero di credere in quello che vuole; al massimo si svilupperanno pratiche inutili ai fini della produttività agricola, come seguire influenze astrali o affidarsi a pratiche esoteriche. Altro è però chiedere i contributi allo Stato e l’inserimento della biodinamica nelle cattedre di agraria, e qui la Scienza deve dire la sua. Questo è invece il testo che è stato approvato al Senato nel Ddl:
“Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell’agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo”.
Notare che il metodo agricolo biologico è riconosciuto da circa trent’anni ed è regolato secondo rigide norme dell’UE, mentre il metodo biodinamico non è altrettanto regolamentato. A questo punto, visto che il Ddl deve ripassare alla Camera per l’approvazione, basterebbe scorporare i due termini invece di omologarli. Vedremo se Galileo conta ancora qualcosa e se il pensiero scientifico italiano riesce ancora a farsi capire dalla gente. Col Covid-19 si è visto di tutto, quindi stiamo in guardia!
Note:
****************************