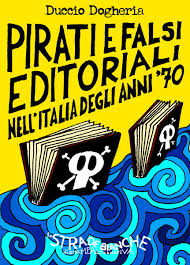Nel momento in cui scrivo si è svolta la conferenza di Berlino senza che nessuno dei due contendenti abbia firmato il protocollo finale. La tregua regge, grazie anche alla mediazione russa, ma Haftar blocca la metà dell’export di petrolio libico “perché lo chiede il popolo” (già sentita altrove), dimostrando di marcare stretto il suo avversario e di avere una strategia alternativa alle armi. Ma comunque vadano le cose, noi italiani siamo fuori o almeno al margine del Grande Gioco, gestito da ben altri attori e condotto da eserciti più o meno organizzati. E se cerchiamo di andare oltre le dichiarazioni alla stampa, non ci vuol molto a capire che dietro alle dichiarazioni dei nostri politici c’è poco: dopo aver per settimane detto che era auspicabile una soluzione negoziata (banale) e che si doveva fare ogni sforzo per la pace (id.), siamo disposti a mandare i nostri militari solo ad acque ferme, ma in genere i soldati si mandano per placare le onde. Sempre meglio dei quattordici mesi durante i quali agli Esteri c’era Moavero Milanesi: della Libia vedevamo solo l’incubo degli immigrati trascurando il resto. Sicuramente paghiamo gli errori del 2011, quando pressati da Francesi e Americani la guerra ce la siamo dichiarata da soli e il debole governo Berlusconi scaricava l’amico Gheddafi da un giorno all’altro. Lo stesso Berlusconi che ora lamenta la mancanza di un nuovo Gheddafi e irride i nostri attuali ministri fu in realtà corresponsabile del caos successivo: nessuno infatti aveva un progetto per il dopoguerra in un paese dove convivono 140 clan e dove non c’era un parlamento. Ma stare alla finestra, auspicare la pace o il negoziato o pensare a un embargo delle armi quando nel frattempo tutti hanno fatto quello che volevano resta poco più che una tardiva esercitazione retorica. Anche a Berlino si è parlato di interrompere il flusso delle armi, ma chi si doveva rifornire l’ha già fatto da tempo. Chi passa alle armi la guerra vuole vincerla e poco si cura del resto. In più, imporre un embargo significa far uscire le navi da guerra per farlo rispettare. La verità è che il governo italiano ha perso un anno di tempo e partiva male, visto che il rappresentante politico riconosciuto dalle Nazioni Unite e da noi patrocinato si è rivelato troppo debole. Non è tutta colpa nostra: Obama ce lo aveva raccomandato, ma Trump, il nuovo presidente, decideva che la Libia non era strategica per la politica americana e noi ci siamo trovati soli non solo contro Haftar, mediocre militare di carriera, ma anche contro i suoi protettori, attori come Russia, Egitto, Arabia Saudita e Francia. Sicuramente i nostri interessi sono in Tripolitania, mentre in Cirenaica avevamo problemi già all’epoca delle colonie. Ma, ossessionati dal problema dell’immigrazione, abbiamo visto corto e del resto neanche Al Serraj ci ha aiutato molto. Messo alle strette da Haftar, alla fine ci ha chiesto armi e soldati che non potevamo comunque dare se non all’interno di un mandato ONU e senza violare l’art. 11 della Costituzione; quindi si è rivolto ai Turchi – musulmani ma non arabi – i quali possono mandare anche una brigata di fanteria senza troppi problemi politici (la logistica è un altro discorso). Dopo un secolo dunque i Turchi si riprendono Tripoli, da cui li avevamo sloggiati nel 1911-12. Al Serraj forse non sa che chiamare in aiuto un esercito straniero significa la perdita di indipendenza e noi italiani ne sappiamo qualcosa, visto che ci abbiamo messo secoli prima di levarci di torno chi voleva governare al posto nostro, né è detto che ci siamo ancora riusciti. Ma questo è un altro discorso. Il paradosso è che siamo in questo momento alleati di una media potenza – la Turchia – che manda in giro mercenari siriani e nel frattempo ha firmato con la Libia un trattato che di fatto spezza in due il Mediterraneo orientale e ipoteca la nostra presenza nella gestione del petrolio libico (le concessioni dell’ENI) e nello sfruttamento della piattaforma naturale fra Cipro e le isole greche. Ma quando una nostra nave ENI è stata cacciata dalle acque attorno a Cipro più di un mese fa non abbiamo battuto ciglio, salvo mandare in crociera da quelle parti una nave della nostra Marina un mese dopo. La prassi diplomatica suggeriva almeno di convocare l’ambasciatore turco per consultazioni. Tenendo presente che quel trattato è illegale pesta i piedi anche a Grecia, Egitto e Israele, forse qualcosa si poteva anche fare. Quanto all’Europa come entità politica, si doveva muovere prima e in modo coordinato, anche se nessuno si fa illusioni sulla sua coesione politica. Ora la Germania ha preso l’iniziativa diplomatica, anche perché dipende molto dal gas e petrolio russi e la partita di gioca su più tavoli, ma l’Italia è stata l’ultima a capire che non si può far niente da soli. Sicuramente l’Europa si è mossa tardi e in modo poco coordinato, ma sappiamo bene che alcuni singoli paesi – penso alla Francia – perseguono da sempre interessi nazionali, che peraltro sanno individuare meglio di noi. D’altro canto i governi Turchi, Russi e Statunitensi sono coscienti che in Europa la guerra non vuole più farla nessuno e si regolano di conseguenza, anche se la diplomazia suggerisce di avvertire almeno gli alleati delle proprie intenzioni: la Turchia è pur sempre un paese della NATO. Purtroppo, la situazione internazionale ricorda l’inerzia del 1938, quando a chi voleva espandersi a spese degli altri fu concesso tutto in cambio di niente, col risultato di scatenare la guerra mondiale che alla fine tutti hanno dovuto combattere. Sicuramente l’attuale sistema delle relazioni internazionali e del bilanciamento delle potenze limita il rischio di una guerra su larga scala, ma i conflitti locali o per procura mostrano da tempo i limiti delle Nazioni Unite nel saperli evitare e gestire. Si direbbe che il trend attuale è la distruzione degli stati deboli e non allineati e la successiva spartizione in zone d’influenza, com’è avvenuto in Iraq e in Siria. Sono conflitti misti, dove si vedono sul campo sia eserciti regolari che bande irregolari, più formazioni di duri mercenari legate ai governi in campo(rispettivamente siriani al servizio dei Turchi e il neanche tanto misterioso Gruppo Wagner gestito dai Russi, più sudanesi e forse chadiani . A Berlino si è detto di disarmare le milizie (600 circa, divise fra 140 clan, ndr.) ma nessuno ha parlato di mercenari, segno che per ora è un problema di difficile soluzione. Comunque vadano le cose, la Libia potrebbe essere di fatto spartita tra Russia e Turchia, vista la sua divisione storica fra Tripolitania e Cirenaica, più a sud l’enorme Fezzan. Fu infatti proprio l’Italia coloniale a unificare il paese, percorso proseguito da Gheddafi nei suoi 42anni di potere, durante i quali comunque egli fece anche gli interessi del suo popolo. Dal canto nostro potevamo offrire tecnologia e infrastrutture in cambio di petrolio, quindi possiamo dire benissimo che Italia e Libia avevano economie complementari. Come andrà ora ancora non lo sa nessuno, ma è intuitivo pensare che ditte turche e russe si guadagneranno le concessioni petrolifere scalzando l’ENI e forse anche i Francesi, la cui condotta politica ha sfiorato la diplomazia parallela ma poco può fare con attori del calibro dei Russi. Tutto il resto a noi in fondo interessa poco, ma proprio per questo la nostra politica estera avrebbe dovuto essere meno passiva. E qui una nota personale: quando parlo con amici stranieri di un certo livello culturale, non è facile spiegar loro perché un paese messo da Madre Natura in mezzo al Mediterraneo non riesca mai ad avere un ruolo di protagonista, e questo non solo dal secondo dopoguerra. Le ragioni le spiegava l’ambasciatore Sergio Romano: perché non sappiamo identificare gli interessi nazionali. A questo aggiungo l’opinione di Edward Luttwak: perché non abbiamo una forte coesione nazionale. Di mio aggiungerei: perché attualmente abbiamo una classe politica ma non una vera classe dirigente. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Archivi tag: Marco Pasquali
“Vento fa bene ai sogni” (Peter Handke)

Il premio Nobel per la letteratura è sempre stato qualcosa di anomalo rispetto agli altri: se è oggettivamente possibile stabilire un metro di giudizio per valutare i contributi scientifici, siano essi elaborazioni teoriche o risultati di ricerche di laboratorio, è impossibile giudicare la letteratura col metodo sperimentale. Con quale autorità si può valutare un’opera scritta in una lingua diversa dalla tua, riuscendo a entrare nella cultura e nella mentalità della società all’interno della quale è stata concepita? E quali sono i fondamentali su cui basare il giudizio, a parte la capacità di interpretare il proprio tempo o di affrontare temi umani universali? E quanti membri della Reale Accademia Svedese delle Scienze hanno mai scritto un romanzo o una poesia o almeno qualche saggio di critica letteraria? Alla fine l’Accademia finisce per valorizzare scrittori mai sentiti o – al contrario – santifica in ritardo i santoni della letteratura internazionale ancora in vita. Positivamente, si sono anche valorizzate letterature minori, si direbbe con alternanze precise fra culture e continenti e contro il conformismo della critica letteraria mainstream, soprattutto anglo-americana. A trarne vantaggio spesso sono stati i piccoli editori, miracolati da un’impennata delle vendite del libro di un oscuro poeta africano (Wole Soyinka) o di un mitteleuropeo sopravvissuto a due guerre e salvato dal museo delle culture estinte (penso a Jaroslav Seifert, a Elias Canetti, a Isaac Bashevis Singer). Tutti i premiati sono campioni della parola scritta, con alcune eccezioni, visto lo sberleffo del Nobel a Dario Fo o la bizzarra scelta di santificare Bob Dylan, i cui testi sono inscindibili dalla performance musicale. Ma almeno Bob Dylan tutto ha fatto meno che premere e tramare per il premio, diversamente da Heirich Boll e Gunther Grass, che in questo somigliavano a certi loro personaggi. Ufficiale invece il pressing operato per tre volte dalla nostra Accademia dei Lincei a favore di Mario Luzi, finché il Nobel a Dario Fo ha convinto l’Accademia a non proporre mai più nessuno. Ma sarà un caso che il numero delle traduzioni in svedese di opere letterarie straniere sia sempre molto alto? E che dire delle occasioni mancate, da Jorge Louis Borges a Philip Roth, tanto per dirne almeno due? E che fine hanno fatto alcuni illustri sconosciuti di cui nulla sapevamo? Date per curiosità un’occhiata all’elenco ufficiale (1) e chiedetevi chi sono alcuni dei premiati e che fine hanno fatto i loro libri. Tra l’altro, gli scandinavi sono proprio bravi: in 112 anni, 15 vincitori provengono da Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda. I nomi? Non solo i noti Selma Lagerlof e Knut Hamsun e il meno noto Johannes Vilhelm Jensen (autore de La Gradiva, analizzata da Freud e Jung) , ma anche Bjornstjierne Bjornson, Carl Gustav Verner von Heidenstam, Karl Adolph Gjellerup, Henrik Pontoppidan, Sigrid Undset, Erik Axel Karlfeldt, Par Fabian Lagerkvist, Halldor Laxness, Nelly Sachs, Eyvind Johnson, Harry Martinson, Tomas Transtromer. Quanti di noi hanno letto le loro opere?
Detto questo, parliamo di Peter Handke, sulla cui premiazione sono piovute pesanti critiche per le sue simpatie dichiarate per la Serbia. Diciamo intanto che proprio per questo l’Accademia si è dimostrata più coraggiosa del solito, oppure non ha capito bene che la letteratura super partes non esiste. Generica come al solito la motivazione: “per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell’esperienza umana” (si vedano tutte le altre: sembrano scritte in serie da uno svogliato professore di liceo). Ma chi è Peter Handke? Austriaco, classe 1942 e attivo dal 1966, ha dato il meglio di sé nella seconda metà del secolo scorso e le oltre cento traduzioni in italiano delle sue opere, oltre che ben curate, dimostrano un notevole interesse da parte dei nostri editori, anche se da noi Handke resta un autore d’élite. Il grosso pubblico lo conosce soprattutto per la sceneggiatura del film di Wim Wenders Il cielo sopra Berlino (1987), ma la sua attività letteraria comprende anche romanzi, articoli, saggi, pezzi teatrali, poesie e resoconti di viaggio. Diciamolo: è uno scrittore completo. Ricordiamo il romanzo Prima del calcio di rigore (1970), da cui Wim Wenders trasse un film, ma anche la pièce teatrale Insulti al pubblico (1966), il romanzo Breve lettera di un lungo addio (1972), la sceneggiatura di Falso movimento (1975), La donna mancina (1976), Storia con bambina (1981), Pomeriggio di uno scrittore e Intervista sulla scrittura (1987). Cito solo alcune opere tradotte e note al pubblico italiano, ma la sua produzione è ben più vasta e continua; l’ultima opera è del 2016, anche se culturalmente Handke resta uno scrittore del secolo scorso. Mi preme però focalizzare la nostra attenzione su due diari viaggio, da noi entrambi stampati da Einaudi: Un viaggio d’inverno ai fiumi Danubio, Sava, Morava e Drina, ovvero giustizia per la Serbia (1996) ; Un disinvolto mondo di criminali. Annotazioni a posteriori su due attraversamenti della Jugoslavia in guerra – marzo e aprile 1999 (2000). Sono diari rivelatori del suo atteggiamento verso la guerra civile jugoslava e le operazioni della NATO contro la Serbia di Milosevic’( 1999), culminate nei 72 giorni di bombardamento di Belgrado. E’ una guerra di cui mi sono già occupato (vedi: Perché la NATO ha bombardato la Serbia, di Biagio Di Grazia) e che vede crimini e responsabilità ben distribuite fra le diverse etnie che componevano la federazione. Rifiutandosi di attribuire le colpe a una parte sola, quella di Peter Handke è stata una voce fuori dal coro, che gli ha provocato la censura di tutta la cultura europea e americana, nonché le rimostranze delle vittime del massacro di Srebrenica (1995) e dei politici e accademici albanesi e kosovari. Dal canto suo Handke ha dichiarato di aver manifestato un pensiero a titolo di scrittore e non di giornalista e che le sue non sono idee politiche, il che è egualmente discutibile. Lessi all’epoca con interesse Un viaggio d’inverno.. (vedi supra) e devo ammettere che, pur essendo osservazioni e appunti di viaggio di uno scrittore e non di un giornalista, la politica non è non può rimanere estranea alla narrazione. Lui descrive quello che vede e non deve dimostrare nulla, ma il messaggio profondo mina le certezze del lettore abituato a vedere tutto in televisione. Alla base dell’atteggiamento di Handke c’è però un elemento forte: sua madre apparteneva alla minoranza slovena che vive in Austria – in Carinzia, zona di confine – minoranza che abbiamo anche noi italiani in Friuli e a Trieste. La Slovenia è stata per mille anni una colonia austriaca, separata dall’Impero asburgico solo da Napoleone e poi diventata autonoma dopo il 1918, con la fine dell’Impero. Ma anche oggi chi va in Slovenia ha l’impressione di trovarsi in un paese di lingua slava ma di cultura germanica. In sostanza, la Jugoslavia ha dato dignità e identità agli sloveni e le operazioni contro la Serbia avevano lo scopo di distruggere il non allineamento della regione all’imperialismo americano. Tesi non solo di Handke, ma da lui portata avanti come questione innanzitutto di identità, che è il problema con cui si deve misurare qualsiasi scrittore. In effetti, Austria, Germania e Vaticano riconobbero immediatamente la secessione slovena (1991), favorendo di fatto la guerra civile e la disintegrazione della Jugoslavia fondata da Tito, il quale però non aveva mai considerato la Federazione una pura espansione della Serbia, come invece Milosevic’ e prima di lui il Regno di Jugoslavia (1929). Peter Handke andò addirittura a trovare Milosevic’ all’Aja e affermò pubblicamente che non era un dittatore e il macellaio dei Balcani come la propaganda lo dipingeva, ma neanche ha mai socializzato con i politici serbi, per quanto riconoscenti. Questo perché per uno scrittore la Serbia diventa una metafora, esempio di de-realizzazione dell’informazione. “Tutti si aspettavano che iniziassero i bombardamenti – scrisse nel 1999 in un’intervista – ma quando accadde davvero, fu come una finzione, come se non fosse reale… Ma è divenuto reale!”
Note
Kosovo: Un riconoscimento dopato

A seguito della dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008, molti paesi hanno assunto una posizione ufficiale sul riconoscimento o meno della sovranità del territorio balcanico a status conteso. Ricordiamo che l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia era stata fortemente voluta dagli Stati Uniti, in aperto contrasto con la Russia e dopo i pesanti bombardamenti condotti dalla NATO nel 1999. Proprio la Russia è nel frattempo divenuta la nazione protettrice della Serbia, cosa non nuova ma favorita da una politica americana incapace di capire una realtà complessa come i Balcani. Nel successivo gioco diplomatico alcuni paesi hanno nel frattempo ritirato il loro voto positivo, forse su pressione esterna. Vi invito a leggere questa tabella (fonte: Wikipedia).
Indice
• 1 Paesi che hanno riconosciuto l’indipendenza
• 1.1 Membri dell’ONU
• 1.2 Non membri dell’ONU e altre organizzazioni sovranazionali
• 2 Paesi che non riconoscono il Kosovo
Al 2018 il Kosovo è stato formalmente riconosciuto come Stato indipendente da 113 dei 193 membri dell’ONU, tra cui i confinanti Montenegro, Macedonia e Albania. Tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, il Kosovo è riconosciuto da Stati Uniti, Francia e Regno Unito, mentre la Russia e la Cina continuano a considerarlo una provincia autonoma della Serbia. Entro il 27 luglio 2019, 14 Stati membri delle Nazioni Unite hanno ritirato il riconoscimento della Repubblica del Kosovo.23 dei 28 paesi dell’Unione Europea hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo. Vi si oppongono Spagna, Cipro, Romania, Slovacchia e Grecia.
- Membri dell’ONU
Afghanistan, Albania, Costa Rica, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Turchia, Australia, Germania, Senegal, Lettonia, Danimarca, Estonia, Italia, Lussemburgo, Perù, Belgio, Polonia, Austria, Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Islanda, Slovenia, Finlandia, Canada, Giappone, Croazia, Monaco, Ungheria, Bulgaria, Liechtenstein, Corea del Sud, Norvegia, Isole Marshall, Nauru, Burkina Faso, Lituania, San Marino, Rep. Ceca, Liberia, Sierra Leone, Belize, Colombia, Malta, Samoa, Portogallo, Macedonia del Nord, Montenegro, Emirati Arabi Uniti, Malaysia, Micronesia, Panama, Maldive, Gambia, Arabia Saudita, Comore, Bahrein, Giordania, Rep. Dominicana, Nuova Zelanda, Malawi, Mauritania, Swaziland, Vanuatu, Gibuti, Somalia, Honduras, Kiribati, Tuvalu, Qatar, Guinea-Bissau,Oman, Andorra, Rep. Centrafricana, Guinea, Niger, Benin, Saint Lucia, Gabon, Nigeria, Costa d’Avorio, Kuwait, Uganda, Ghana, Haiti, Brunei, Ciad, Timor Est, Papua Nuova Guinea, Figi, Saint Kitts e Nevis, Dominica, Pakistan, Guyana, Tanzania, Yemen, Egitto, El Salvador, Thailandia, Grenada, Libia, Tonga, Lesotho, Togo, Isole Salomone, Antigua e Barbuda, Singapore, Bangladesh, Madagascar, Barbados
1.2 Non membri dell’ONU e altre organizzazioni sovranazionali
Taiwan, Isole Cook, Niue
Paesi che non riconoscono il Kosovo
Dopo la lettura e approvazione della dichiarazione d’indipendenza da parte del parlamento kosovaro, è arrivata la replica ufficiale da parte della Serbia, che considera il Kosovo parte inalienabile del suo territorio e culla della sua storia ha minacciato ritorsioni internazionali quali il ritiro degli ambasciatori dai paesi che avrebbero riconosciuto l’indipendenza kosovara. Dal 2017, alcuni Paesi che avevano stabilito relazioni diplomatiche con le autorità kosovare sono poi ritornati sui propri passi: il Suriname nel luglio 2016 aveva riconosciuto l’indipendenza del Kosovo, nell’ottobre 2017, a seguito di colloqui intercorsi con la Russia, revocava il riconoscimento, con conseguente protesta del governo kosovaro che ha tentato di sollevare una disputa internazionale. In precedenza, analoga decisione di revoca era stata assunta da São Tomé e Príncipe. Nel febbraio 2018 il riconoscimento del Kosovo è stato annullato anche dal Burundi.[138], esempio seguito nel gennaio 2019 da Palau e dal Togo nell’agosto del 2019: dunque, sono a oggi 15 gli stati che hanno fatto marcia indietro su pressione di Russia e Serbia. La Guinea-Bissau ha dichiarato, nel novembre 2017, il proprio ritiro ma dopo poco tempo le autorità hanno inviato una nota verbale al governo kosovaro affermando che la revoca non ha avuto alcun effetto. Ancora più strana la scelta delle autorità di Sao Tomè e Principe che, secondo l’ex presidente Manuel Pinto da Costa, non aveva mai riconosciuto l’indipendenza del Kosovo. Infine la Liberia ha revocato il riconoscimento nel giugno 2018 pur confermando il mantenimento delle relazioni bilaterali con Pristina. Al che il governo di Belgrado ha abolito i visti per i cittadini provenienti da questi paesi. Obiettivo dichiarato del ministro degli Esteri serbo Ivica Dačić è infatti quello di ridurre a 96, meno della metà del totale, i paesi dell’ONU che riconoscono il Kosovo come Stato indipendente.
Questi i dati. La loro analisi è complessa ma anche inquietante. Il rifiuto di alcuni paesi dell’Unione Europea è motivato da profonde affinità ideologiche o religiose (Russia, Grecia), oppure dalla paura di favorire analoghe tendenze secessioniste all’interno della propria nazione (Spagna, Romania, Slovacchia, Cipro). E gli altri? In genere i paesi del c.d. Terzo Mondo appoggiano quasi sempre l’indipendenza di nuovi stati, essendo loro stessi nati da un processo di decolonizzazione o di sfaldamento imperiale, ma stavolta hanno visto – e non a torto – l’indipendenza del Kosovo come un problema di equilibri politici europei; di conseguenza sono stati meno solidali con l’ultimo arrivato. Ma quello che turba il sonno è rendersi conto che le decisioni delle Nazioni Unite dipendono non solo dal voto dei membri permanenti con diritto di veto e da decine di stati nazionali più o meno democratici, ma anche dalle decisioni di entità statuali che di fatto sono poco più che sportelli bancari. Per quale motivo il voto della Spagna o dell’Unione Sudafricana vale quanto quello di un paradiso fiscale sperduto nel Pacifico e abitato da tremila anime? E davvero nessuno vende il proprio voto? Ha suscitato scalpore – ma non troppo – la vicenda di un emissario, “un consigliere speciale del ministro degli Esteri serbo” che avrebbe incontrato a Parigi il ministro degli esteri del Togo, Silvi Baipo Temon offrendo circa 350 mila euro in cambio di una nota in favore della revoca del riconoscimento. Avete capito bene: per la stessa cifra si può comprare il voto del Togo o un appartamento al Prenestino. Si spera solo che per decisioni più gravi ci sia più serietà, ma il difetto è strutturale e risiede nel meccanismo stesso di voto di una organizzazione – le Nazioni Unite – nata in altri tempi con ben altre premesse e ben altri membri.
Nazionalismo dei Nazionalismi
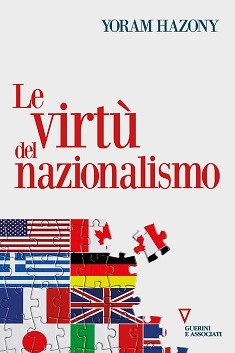
Il 13 novembre è uscito in Italia per i tipi della Guerini il libro del politologo israeliano Yoram Hazony, dal titolo Le Virtù del Nazionalismo Non ho ancora avuto occasione di leggerlo, ma promette bene: si pone controcorrente al pensiero che vede nel nazionalismo, nel sovranismo e nel populismo il male assoluto. Il nazionalismo, che per l’autore coincide con l’autodeterminazione dei popoli e con un mondo di nazioni libere e indipendenti, si oppone all’Imperialismo, cioè a qualsivoglia forma di governo che voglia unire l’umanità sotto l’egida di un unico regime politico. Imperialista, per Hazony, fu, specie dal 1989 a oggi, la politica degli Stati Uniti d’America che, sino a tempi recenti, hanno cercato di imporre una pax americana, ricalcando il modello imperiale della pax romana. Ma imperialista sarebbe pure l’Unione Europea, rispetto alle singole nazioni membro. E qui è facile prevedere una buona accoglienza del libro da parte italiana, almeno da quella parte politica che deve cedere sovranità e interessi nazionali a un’entità superiore di cui non si sente realmente parte, oppure è erosa dalla globalizzazione e dall’ideologia ad essa relativa. Lo studio si dipana partendo dalla Bibbia (l’autore è comunque ebreo) al protestantesimo, scorrendo l’Impero Romano e il Sacro Romano Impero, traversando Locke e il moderno pensiero politico liberale, fino a descrivere l’attuale crisi dello stato moderno occidentale e del suo sistema simbolico.
In attesa di leggere i libro, suggerisco alcune osservazioni:
• Perché concentrarsi solo sull’imperialismo americano, quando Unione Sovietica e Cina hanno non solo condotto la loro politica con procedure tipiche dell’imperialismo, ma hanno imposto il loro modello di vita con la forza e opprimendo le popolazioni meno collaborative?
• L’Impero come forma statuale è stato storicamente accettato dalle popolazioni diverse dal gruppo etnico dirigente non solo perché conquistate militarmente o economicamente, ma perché hanno riconosciuto i vantaggi di una struttura sovranazionale capace di regolare l’economia generale e i conflitti interetnici, nonché di garantire anche possibilità di carriera agli allogeni. Questo indipendentemente dalla cultura superiore che l’Impero è convinto di esportare.
• I punti deboli del nazionalismo sono due: la tutela delle minoranze, spesso più vantata che effettiva; e più grave, la conflittualità. I grandi imperi conducono meno guerre degli stati nazionali, questi ultimi essendo sempre pronti a deflettere sul vicino i conflitti interni e scatenare guerre di confine. In più il movimento di lavoratori tra stati nazionali è ostacolato da frontiere e veti interni volti a ridurre la concorrenza economica.
• Ultimo limite, l’affermarsi di entità sovranazionali, movimenti e organizzazioni basati su basi funzionali economiche. Google, Amazon o le fondazioni gestite da Soros non hanno nessun interesse a trattare in Europa con 27 governi e legislazioni diverse, per cui sono molto più corrosive dello stato nazionale di quanto non lo siano la sinistra terzomondista o la chiesa cattolica ecumenica.
Yoram Hazony è uno dei più vivaci pensatori israeliani contemporanei: filosofo, teorico politico e biblista. Presidente del The Herzl Institute di Gerusalemme, una delle più interessanti nuove istituzioni accademiche israeliane, fondò alcuni anni fa, nel 1994, il prestigioso Shalem Center, un avanzato centro di ricerca e di promozione degli studi umanistici, cercando di integrare tradizione e modernità. Ebreo osservante e sionista, formatosi presso le più insigni università israeliane e statunitensi, è noto in Israele, negli Stati Uniti e nel Commonwealth per i suoi originali contributi agli studi biblici e politici.
Le virtù del nazionalismo
Yoram Hazony
Traduttore: Vittorio Robiati Bendaud
Editore: Guerini e Associati, 2019, pp. 328
Collana: Sguardi sul mondo attuale
Prezzo: € 21,50
ISBN: 9788862507707
EAN: 9788862507707
Pirati e falsi
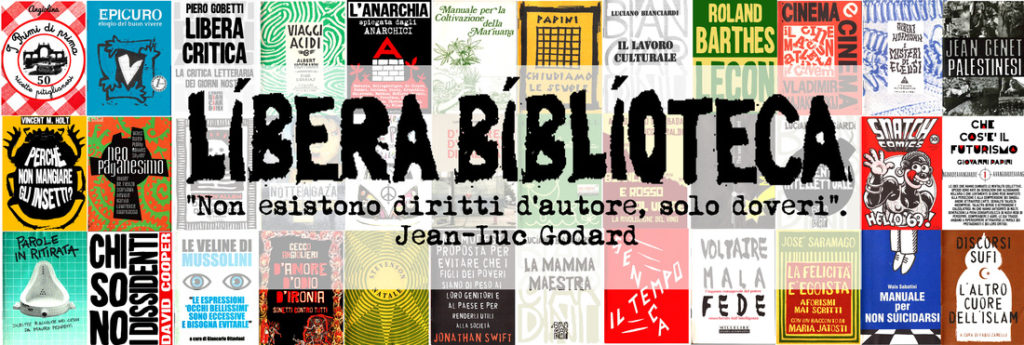
Sono meno di cento pagine, ma preziose: poco o nulla esisteva in argomento, né è stato facile recuperare e mettere insieme una congerie di opuscoli e documenti non tutti registrati dalla Biblioteca Nazionale, stampati con tirature ineguali da collettivi o piccoli editori, pochi dei quali sono rimasti attivi nel lungo periodo. Fa eccezione Stampa Alternativa, che festeggia i suoi primi cinquant’anni di attività e vanta una produzione sterminata tra libri, libelli e quant’altro. E qui va chiarito un concetto: la pirateria editoriale non perseguiva fini commerciali, ma democratici: culturali e politici. Lo stesso vale per i falsi: erano provocazioni che nulla hanno a che spartire con quei prodotti che sfruttano un nome o un marchio famoso per fare quattrini senza pagare i diritti. Ricordo p.es. copie pirata di Love Story e addirittura de Le nozze di Cadmo e Armonia di Piero Citati: quelle 80 pagine erano state rifatte da una tipografia e solo l’occhio del bibliotecario notava le inesattezze sfuggite al cliente di libreria. E girano da sempre edizioni fantasma di Mein Kampf, stampate senza registrazione ma da sempre popolari in certi ambienti. Va detto invece che le indicazioni di stampa che dovevano tutelare i pirati politici sono le più varie: Amsterdam o Londra, con tanto di indirizzo e sigla di fantasia, oppure supplemento di Stampa Alternativa (con la benedizione della testata registrata). Fantomatiche le Edizioni Vuoto a Perdere, altrettanto misteriose le Edizioni del Sole Nero, mentre in una pubblicazione pirata si legge addirittura: stampato a Magonza, presso Gutemberg!
Ma torniamo ai contenuti. Si stampavano essenzialmente opere che ancora non erano state tradotte – testi teorici innanzitutto – o che avevano un costo proibitivo per lo studente. Per abbassare i costi si ricorreva a carta comune, margini stretti, caratteri ridotti e soprattutto distribuzione alternativa, il che significava far arrivare la cultura in luoghi e ambienti fino allora tagliati fuori dalla distribuzione ufficiale. Né si creda che fossero sottoprodotti: la traduzione de La società dello spettacolo di Guy Debord risulta migliore nell’edizione pirata che in quella ufficiale di De Donato (1968). L’edizione a cura de L’Erba Voglio dei Minima moralia di Adorno del 1976 rende giustizia a quella pubblicata da Einaudi nel 1954, molto lacunosa; al punto che l’Einaudi stesso la ristampò integrale nel 1979, concedendo sottobanco ai pirati di esaurire le scorte. Ma l’elenco di opere stampate o tradotte o ristampate senza autorizzazione né royalties è lunga quanto interessante: i libelli femministi stampati da Limenetimena, le edizioni di Anarchismo, poesie e canzoni di Patti Smith, alcuni manuali sudamericani di guerriglia, Céline, Bataille, Evola; alcune opere di Wilhelm Reich su politica e sessualità, già pubblicate su riviste professionali difficilmente accessibili ai più; le opere situazioniste di Raoul Veigenem; La politica dello stupro di Diana E.H. Russell, il famoso S.C.U.M di Valerie Solanas, La morte della famiglia di David Cooper, più opere di Louis-André Salomé, di Gilles Deleuze e Felix Guattari, Michel Foucault, Aldous Huxley… insomma, una bella biblioteca, anche se non rilegata in pelle. Ed è grazie a queste edizioni che molti di noi sono cresciuti culturalmente e politicamente. Stampare senza permesso o rifiutando la SIAE è stata una scelta produttiva e politica di cui oggi sinceramente si sente la mancanza, anche se la Rete ha creato nuovi spazi alla diffusione della cultura.
Parlavamo anche dei falsi. Siamo così abituati al falsario geniale ma venale, da non pensare alle provocazioni dei surrealisti, dei dadaisti, degli anarchici, dei situazionisti. Chi scrive ricorda le false prime pagine dei quotidiani edite da il Male, paradossale esempio di manierismo e satira insieme. Ma sono rimasti nella storia ben altri falsi: l mio testamento politico di Sartre (1978), scritto dagli anarchici di Catania, e soprattutto il Rapporto veridico sulle ultime opportunità di salvare il capitalismo in Italia (1975), scritto da “Censor” (in realtà Gianfranco Sanguinetti). Inviato volutamente nei circoli che contano, fu preso per buono da tutti e proponeva una soluzione per evitare il comunismo estremo e riformare il capitalismo dall’interno. Non doveva essere uno studio teorico superficiale, se fu apprezzato da sindacalisti, industriali e giornalisti, i quali furono poi pubblicamente diciamo “derisi” quando l’autore uscì allo scoperto. Altro capolavoro furono le Lettere agli eretici di Enrico Berlinguer (1977). La veste editoriale ricopiava il format della collana Nuovo Politecnico della Einaudi, per cui approdò in libreria sotto mentite spoglie. Le lettere sono indirizzate a Marco Pannella, Goffredo Fofi, Adele Faccio, Angelo Pezzana, Renato Curcio, Andrea Valcarenghi, Toni Negri. L’ultima lettera è per gli Indiani Metropolitani, considerati collettivamente. Il falso è persino grossolano, ma ci cascarono in parecchi. Autore ne era Pierfranco Ghisleni, il quale rispose a tono a Giulio Bollati, direttore commerciale di Einaudi, accusandolo di non aver capito il senso culturale dell’operazione. Ovviamente il libro fu sequestrato e ora è merce di antiquariato. La cosa buffa è che due di queste lettere apocrife furono ristampate… da un’edizione pirata di Verbania. Nel 1982 Ghisleni diviene direttore del Male, che già dal 1978 si faceva notare per le sue trovate. Nel frattempo il suo editore aveva stampato Esortazione alla Democrazia Cristiana affinché lasci il governo in Italia e passi all’opposizione, scritto da un certo Antoine A. de Toqueville, allusione al grande teorico francese della democrazia. Ma interessante fu il commento di Umberto Eco al falso Sartre (1978): “Negli ultimi due anni: manifesti politici del gruppo A con la firma del gruppo B; il falso epistolario di Berlinguer (…) il falso testo di Sartre (…) Ce ne accorgiamo ancora perché le falsificazioni sono grossolane e tutto sommato inabili o troppo paradossali. Ma se tutto fosse stato fatto meglio e con un ritmo più intenso? Non resterebbe che reagire alle falsificazioni con altre falsificazioni (…) ma proprio questo sospetto mostra il potenziale suicida contenuto nelle tecniche falsificatorie”. Dopo 40 anni, nell’era dell’Internet e delle fake news, che dire?
In appendice, una specie d’intervista al pirata per eccellenza, Marcello Baraghini, fondatore di Stampa Alternativa.
Pirati e falsi editoriali nell’Italia degli anni ’70
di Duccio Dogheria
Edizioni: Le Strade Bianche di Stampa Alternativa, 2018