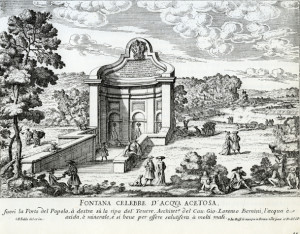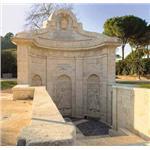Si deve sicuramente a Nicolas Poussin se Ponte Milvio e la campagna circostante acquistarono notorietà nell’Europa del ‘600, diventando luogo di soggiorno per artisti e curiosi, con benefici economici per gli abitanti della zona. Lo sconforto iniziale che prese l’artista francese per un ambiente ostile si trasformò radicalmente in ammirazione per ciò che lo circondava e per la semplicità e generosità di quella gente. Un affetto ricambiato dai pontemollesi che lo adottarono come Sor Pussino. La popolarità di quei luoghi crebbe anche in virtù delle passeggiate che Poussin abitualmente faceva in compagnia di artisti: le famose “promenade” che lo portavano da Ponte Milvio a via Tor di Quinto e da Saxa Rubra fino al Casale del Pussino (come veniva ribattezzato dai pontemollesi, oggi Castello della Crescenza), passeggiate durante le quali incontrava butteri e contadini, bufalari e pecorai che gli mostravano considerazione.
Contemporanei di Poussin nel frequentare Ponte Milvio, ma in modo sporadico, furono gli artisti raccolti sotto l’appellativo di Bambocciani. Una banda chiassosa di pittori fiamminghi, olandesi e italiani che prese dimora in via Margutta, conferendole quel ruolo di strada degli artisti che tuttora mantiene.
Joseph Mallord William Turner raffigurò Ponte Milvio in una serie di tele e disegni dedicati alla Campagna romana, mentre dieci anni dopo celebre è il dipinto di Camille Corot (1828), attualmente custodito al Louvre, dove è raffigurato Ponte Milvio.
Con il passare degli anni “Ponte Mollo” divenne il luogo di incontro degli artisti che provenivano dal nord: una vera e propria istituzione che, nel primo ventennio dell’ottocento, si trasformò nel circolo conosciuto come Pontemolle Gesellschaft.
Artisti importanti come Thorvaldsen, Cornelius, Andersen, Reinhart e Millin diventarono una congrega di buontemponi, che riservavano ai nuovi arrivati un caloroso benvenuto con gaie cantate, che terminavano all’osteria con un bicchiere di vino.
Avevano una loro insegna sociale: una fojetta (bicchiere) vuota col motto Praeses Populusque Pontemollicus e un Bajocco, una grossa medaglia con nastro azzurro, una sorta di “decorazione” in segno della ammissione al caratteristico sodalizio. Un senso di appartenenza al quale tenevano molto: Thorvaldsen scelse addirittura di sfoggiare solo questa goliardica “onorificenza” dell’Ordine del Bajoccoda, nonostante ne avesse ricevute molte altre in Europa, durante le cerimonie di Corte quando tornò nella sua Copenhaghen.
Dal Seicento di Nicolas Poussin, che visse in una sorta di Arcadia destinata a committenti facoltosi, si passa al Settecento che utilizzò le osterie di Ponte Milvio come luogo espositivo e di promozione del lavoro dei novelli pittori e di illustri artisti.
Il gruppo del “XXV della Campagna Romana”, formato da artisti italiani, incarnò, sino ai primi anni del ‘900, la tradizione della “Società di Ponte Mollo”(Pontemolle Gesellschaft).
Ancor oggi Ponte Milvio è un luogo d’incontro culturale grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Capitolina: nella Torretta, infatti, sono da tempo ospitate numerose iniziative artistiche, esposizioni di arte contemporanea aperte ad ogni ambito espressivo, mentre alcuni artisti preferiscono mostrare in modo informale le proprie opere nel vicino mercato.